

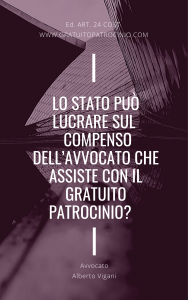
Può lo Stato lucrare sul gratuito patrocinio?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020, ha aperto nuovamente un dibattito sull’entità delle somme liquidate dal giudice in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in comparazione con quanto liquidato dal giudice a carico della parte soccombente in favore dello Stato.
Invero, al momento della liquidazione del compenso all’avvocato che assiste in regime di patrocinio a spese dello Stato, quanto di spettanza del difensore viene quantificato in misura ridotta rispetto alla tabellazione prevista per DM, dal 50 al 30 % in meno (rispettivamente nel civile e nel penale), mentre nulla si dice di quanto deve pagare controparte.
Il TUSG DPR 30/05/2002, n. 115, dispone che, in generale:
Art. 82 DPR 115-2002 (Onorario e spese del difensore)
Il compenso del patrocinio a spese dello Stato in ambito civile viene dimezzato ai sensi del disposto del TUSG DPR 30/05/2002, n. 115:
ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
L’importo dovuto viene determinato con riferimento alla tabellazione prevista con decreto ministeriale (ad oggi il DM 55/2014 e successive modifiche) e, pertanto, ai sensi del TUSG il legale civilista ammesso al gratuito patrocinio riceverà dallo Stato i compensi nella misura ridotta del 50% (appunto la metà).
La valutazione comparata fra quanto liquidato a favore del patrocinio del non abbiente vittorioso e quanto determinato a carico del soccombente avversario deve fare riferimento all’art. 91 cod. proc. civ., che usa appositamente il termine “rimborso” immettendo nell’ordinamento una norma inderogabile.
Art. 91 – Condanna alle spese
Il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare … (omissis).
La detta previsione legislativa, in sé apparentemente semplice, non vede rigorosa applicazione a seguito della diffusa deroga che vede sovente omettere la totale rifusione delle spese sostenute in concreto dalla parte vittoriosa.
Per questa ragione, la recente sentenza accentua questa disapplicazione di fatto, ritenendo che quanto liquidato a favore del patrocinio del non abbiente vittorioso possa essere diverso ed inferiore a quanto posto a carico del soccombente, tenuto a rifondere però l’Erario e non la controparte processuale.
Infatti, il disposto legislativo prevede che, qualora la parte ammessa al patrocinio vinca la causa e quindi abbia diritto alla rifusione delle spese legali da parte del soccombente, detto pagamento spetti allo Stato ai sensi del TUSG DPR 30/05/2002, n. 115:
ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)
La sentenza oggi in commento, Cass. n. 19 del 3 gennaio 2020, sposa una corrente giurisprudenziale successiva ad un precedente – ma non superato – orientamento che impedisce che lo Stato possa incassare di più di quanto viene pagato al difensore del patrocinio per i non abbienti.
Sul punto, infatti, si registrano successive ed opposte statuizioni:
Si viene così a ipotizzare, in via speculare al rischio di danno erariale, anche un possibile indebito arricchimento in capo allo Stato qualora le spese liquidate a favore dell’erario per la vittoria dell’assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato sia superiore a quanto effettivamente riconosciuto quale compenso professionale all’avvocato che ha garantito una vittoriosa tutela dei diritti del non abbiente.
Buona conferma dei principi espressi fin qui arrivava con Cass. civ. n. 18167/2016, ove si sottolinea che una diversità fra (I) liquidazione e (II) condanna alla rifusione disconoscerebbe la vera ratio dell’istituto della rifusione delle spese legali, il quale mira unicamente a tenere indenne la controparte dei costi sostenuti per la propria difesa, senza perseguire ulteriori finalità di stampo punitivo. Peraltro,, il principio espresso dalla Corte, traendo fondamento da principi generali, e non settoriali, dell’ordinamento, si afferma connotato da una notevole vis espansiva, in virtù della quale esso si presta a trovare applicazione non solo nell’ambito del processo penale, ma anche nel settore più ampio dei giudizi civili.
In coerenza a tale enunciazione era poi seguita la medesima Cassazione civile con l’ordinanza n. 21611 19 settembre 2017 che aveva confermato: “... qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale“.
Con quest’ultima sentenza, si ha la conferma dell’individuazione di un possibile di ingiusto profitto in capo all’erario.
In epoca intermedia vi era stato anche un richiamo della Consulta che aveva recepito il principio in una sua motivazione (in sentenza n. 270/2012) affermando ” … laddove al fine di escludere i dubbi di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 sollevati dalle ordinanze di rimessione, ha escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva puntualizzato che la somma che, ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 133, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente ...“.
Di contenuti analoghi è anche la più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2016.
***
Ebbene, se la recente scelta è fondata sui cinque motivi descritti, si deve rilevare che questi non convincono già per i loro contenuti immotivatamente asimmetrici e, poi, pare necessario aggiungere che essi paiono persino demoliti dalla coeva (ma non citata) giurisprudenza di legittimità, oltre che negati dalla stessa giurisprudenza costituzionale erroneamente invocata a proprio suffragio.
Per dare analitica contezza delle critiche appare pratico argomentare secondo il medesimo ordine proposto nella sentenza in commento.
La questione non pare pertinente perché non si ravvede alcun riferimento normativo che giustifichi un limite al Giudice penale nella diversificazione della liquidazione fra compenso a favore del procuratore e rifusione delle spese a favore dell’erario.
La disciplina citata dalla massima non ha, infatti, alcuna riserva a favore del settore penale.
L’art. 106 bis prevede solo una diversificazione della riduzione del compenso, e nulla altro, mentre l’art. 110 non crea alcuna riserva particolare a favore del processo penale.
Art. 106-bis DPR 115-2002 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato)
Come accennato sopra, nell’affermare una diversità di disciplina, parimenti di alcuna utilità è l’art. 110.
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
In difetto dell’affermata distinzione delle modalità di liquidazione in ambito civile e penale, cade ogni deduzione difensiva sul punto.
D‘altro canto, il principio espresso dalla Corte di legittimità è pure confermato dall’ordinanza n. 270/2012 del Giudice delle leggi ove si sottolinea che, traendo fondamento da principi generali, e non settoriali, dell’ordinamento, quanto statuito risulta connotato da una notevole vis espansiva, in virtù della quale esso si presta a trovare applicazione non solo nell’ambito del processo penale, ma anche nel settore più ampio dei giudizi civili.
Non solo: secondo la Corte Costituzionale (n. 122/2016) il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, rappresenta un mero inconveniente di fatto irrilevante nel giudizio di costituzionalità: a nulla giova quindi darne conto.
Per quanto invece riguarda il proposito di recuperare somme all’erario, la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 270/12 precisa che, “nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato …. non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi – giustificata, per come dianzi dimostrato, dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce – tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario“. Per l’effetto, se il recupero di somme da parte dell’erario ha sempre una connotazione di esazione di un qualche genere, si deve qui vedere negata ogni attività in tal senso a mezzo la diversa quantificazione delle spese legali a favore dell’erario rispetto a quanto liquidato vero il patrocinatore in regime di beneficio di Stato.
Nella vicenda che ci riguarda oggi non si ha alcuna disparità sul piano legislativo, ma solo il tentativo di dare una lettura differenziata a norme che prevedono il medesimo risultato, con ciò violando ogni riserva di legge sul punto.
A dirla tutta, nella recente sentenza della Suprema Corte n. 11590/2019 citata in provvedimento commentato si afferma che vi una diversa tempistica nelle liquidazioni del processo civile e del processo penale e ciò consentirebbe di non estendere meccanicamente il modello in uso in ambito penalistico, dove – a differenza che nel civile – la liquidazione avverrebbe nel medesimo dispositivo: il tentativo di sviluppare tale tematica risulta però controproducente perché – a partire dalla finanziaria 2016 – anche nel processo civile si ha l’obbligatoria liquidazione in contestualità al provvedimento che chiude la fase processuale alla quale le spese sono inerenti (art. 83, comma 3 bis del DPR 115/2002).
Art. 83 (L)
(Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. (1)
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Se quindi si cercava un vincolo a contrariis, ora si può dire che tale specificazione è diventata conferma del poter applicare al civile il principio che si dava per pacifico nel penale.
Del pari è del tutto ininfluente quanto affermato circa il minor numero di avvocati disponibili, perché quanto conta non è invocare una maggior liquidazione a favore del procuratore, in emulazione di quanto può accadere nel regime ordinario o per il processo penale, bensì il ribadire che non esiste alcuna ragione plausibile per sostenere una maggior rifusione a favore dell’erario.
Per tutti i motivi dedotti, il provvedimento da ultimo occorso risulta non equilibrato e persino collassante nei suoi punti fondanti proprio per non esser riuscito a superare le migliori ragioni delle opposte statuizioni della Cassazione e della Corte Costituzionale.
Visto che, in materia di TUSG, la medesima Suprema Corte ha riconosciuto una particolare autorevolezza alle pronunce della propria IV sezione (vedasi di seguito Cass. n. 20552/2019) alla quale vengono rimesse le questioni in tema di applicazione del decreto presidenziale 115/2002 e la quale ha già mutato in senso opposto il suo orientamento, si evidenzia che la sentenza in commento è stata pronunciata dalla II sezione: anche per questa ragione, ma anche per la contraddittorietà con altre maggioritarie e coeve pronunce della Suprema Corte e persino con precedenti di giurisprudenza costituzionale, non si può che confidare ed auspicare in un intervento delle Sezioni Unite.
Riportiamo di seguito tutta la giurisprudenza di riferimento sia in massima che in testo integrale, con evidenziate le parti di maggior rilievo.
per Associazione Art. 24 Cost.
***
INDICE
ART. 24 COST.
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24456-2015 proposto da:
D.C., quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con successivo decreto del 13/2/2015, il Tribunale liquidava in favore del D. la minor somma di Euro 1.500,00, oltre accessori, e l’opposizione proposta dallo stesso difensore, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 era rigettata dal Tribunale con ordinanza del 25/8/2015.
Rilevava il provvedimento che non poteva accedersi alla tesi del professionista secondo cui vi doveva essere necessaria coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a favore dello Stato e quella poi riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il richiamo al precedente del giudice penale costituito da Cass. pen. 46537/2011 non era pertinente in quanto non teneva conto del meccanismo delle spese processuali nel suo complesso.
In effetti, le spese legali costituiscono solo una parte delle spese che devono essere sopportate dal cittadino per l’accesso al servizio giustizia, occorrendo tenere conto anche della necessità del versamento del contributo unificato, dei compensi dovuti al difensore e dei relativi accessori, nonché delle imposte di registro eventualmente dovute.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’esenzione dal pagamento di alcune spese e l’anticipazione di altre da parte dell’erario, nonchè modalità differenti di determinazione dell’onorario del professionista, essendo espressamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 che gli importi spettanti al difensore sono ridotti alla metà.
Inoltre, a seguito dell’ammissione, l’interessato non deve versare il contributo unificato, le spese per le notificazioni richieste d’ufficio, alcune imposte nonchè i diritti di copia, essendo poi anticipati dallo Stato gli onorari e le spese dovute al difensore.
Ne deriva quindi che, in caso di vittoria del patrocinato, il giudice dispone che il pagamento delle spese da parte del soccombente avvenga in favore dello Stato, spese che però non comprendono solo gli onorari dell’avvocato, ma, per la differenza che può esistere tra quanto liquidato a carico del soccombente e quanto liquidato a favore del difensore, mirano a compensare i maggiori oneri a carico dello stesso Stato, il che esclude che possa ravviarsi un ingiustificato arricchimento a favore di quest’ultimo.
Avverso tale ordinanza D.C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste l’Amministrazione ai soli fini della discussione orale.
La causa, inizialmente fissata per la trattazione dinanzi alla VI sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 1977/2017 del 25 gennaio 2017 è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendosi ravvisate le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. Quindi è stata fissata l’udienza di discussione del 2 ottobre 2019.
Infatti, oltre a doversi considerare che la sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto aveva operato un’eccessiva decurtazione delle competenze richieste dal ricorrente, liquidando la somma di Euro 3.500,00 (di cui Euro 2.090,00 per onorari) a fronte del ben più elevato importo di cui alla nota specifica ivi depositata (pari ad Euro 14.767,00), il decreto di pagamento ha effettuato un’ulteriore decurtazione, facendo sì che lo Stato possa recuperare dal soccombente condannato al pagamento delle spese processuali una somma in realtà mai sborsata, favorendo così un’iniusta locupletatio da parte dell’erario.
Pertanto al ricorrente andava liquidata la medesima somma alla quale era stato condannato il soccombente nel giudizio di merito.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove ha escluso la pertinenza dell’argomento costituito dal richiamo alla giurisprudenza penale di legittimità circa la coincidenza tra la liquidazione fatta a carico del soccombente e quella in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre sarebbe priva di giustificazione la deduzione secondo cui l’eventuale differenza tra le somme separatamente liquidate verrebbe a compensare i maggiori oneri che lo Stato sopporta nel caso di ammissione al patrocinio, in assenza di una puntuale indicazione di tali maggiori oneri.
Si sostiene poi che non avrebbe senso che il Tribunale di Sciacca, nel condannare il Mo., avesse posto in essere una condanna ad una somma meramente virtuale o ipotetica, posto che, per la differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto liquidato in decreto, la parte ammessa al patrocinio non avrebbe alcun titolo esecutivo per recuperare la stessa nei confronti del soccombente, confermandosi in tal modo la necessità che debba esservi coincidenza tra le due liquidazioni.
2.1 I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
In disparte l’ammissibilità della denunzia di illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non palesando il ragionamento del giudice di merito i connotati di anomalia che secondo la giurisprudenza di questa Corte permettono di riscontrare un’abnormità nella motivazione tale da incidere sulla stessa validità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui è necessario che ricorra una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero una “motivazione apparente”, o ancora un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), le critiche si risolvono nella riproposizione a questa Corte della questione relativa alla necessità o meno di una corrispondenza tra gli importi liquidati in sentenza a carico del soccombente, e con sostanziale distrazione in favore dello Stato, e quelli invece oggetto del separato decreto di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, un primo orientamento di questa Corte, partendo dalle affermazioni contenute in Cass. pen. 9 novembre 2011 n. 46537 (richiamata anche nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. predisposta in vista della trattazione in udienza camerale e depositata in data 26/10/2016), era pervenuto alla conclusione secondo cui, qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. sez. VI, 16/09/2016, n. 18167).
Ritiene però il Collegio di dover dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa Corte che, rivedendo la propria iniziale posizione, ha invece escluso che possa costituire vizio del decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, l’eventuale differenza tra gli importi di tale liquidazione e di quella adottata carico del soccombente nel giudizio di merito.
In tal senso Cass. n. 22017/2018 ha affermato che il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. n., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (in senso conforme Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019).
Infine la questione è stata oggetto della recente sentenza n. 7560/2019, non massimata, resa all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa da precedente udienza camerale, proprio al fine della risoluzione della questione avente rilevanza nomofilattica, la quale ha ribadito che nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla normativa di materia. Pertanto, pur voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente, resta fermo però che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.
Ritiene il Collegio che debba assicurarsi continuità a tale principio.
In tal senso, va ricordato che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 2, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Infine l’art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la suddetta disciplina non lede il principio di parità di trattamento a causa del particolare criterio di remunerazione delle attività prestata in favore dei non abbienti, poiché il sistema è caratterizzato da peculiari connotazioni pubblicistiche e la riduzione dei compensi ai sensi dell’art. 130 t.u.s.g. non impone al professionista un sacrificio tale da “risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una – parzialmente diversa – modalità di determinazione del compenso giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario” (cfr., testualmente, Corte Cost. 122/2016; Corte Cost. 270/2012). Quanto alla potenziale lesione del diritto di difesa per effetto “della più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile le parti non abbienti (data la minore rimuneratività di tale attività)”, può al più prospettarsi, non un vizio di costituzionalità, ma “un mero inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione” (Corte Cost. 270/2012).
Una volta ribadita la legittimità del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 130, nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla suddetta normativa, il che comporta che anche a voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente (come appunto ritenuto da Cass. 18167/2016 e da Cass. pen. 46537/2011, ed in motivazione da Corte Cost. 270/2012), tuttavia il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.
Nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme inferiori a quelle liquidate in sentenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., legittimata a dolersi è esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poichè “presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalità “punitiva” del tipo di quella ora prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018).
2.2. Orbene, alla luce di tali principi, e tornando al caso in esame, il ricorrente lamenta una prima riduzione della liquidazione delle spese di lite, come operata nel giudizio di merito, rispetto a quanto richiesto nella nota specifica, ma senza che però si deduca che la liquidazione effettuata dal giudice a quo, nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 sia violativi dei minimi tariffari imposti per legge.
Ma ancor di più, e passando alla questione delle spese come liquidate nel decreto oggetto di opposizione, non si lamenta che la liquidazione delle competenze nell’ammontare di Euro 1.500,00, quale risultante dalla decurtazione del 50 % imposta dal menzionato art. 130, in ragione della natura civile della controversia nella quale è stata prestata l’attività defensionale, sia a sua volta avvenuta in violazione dei minimi tariffari, attesa anche l’assoluta genericità delle allegazioni difensive che omettono di riferire sia del preciso valore della controversia di merito sia delle specifiche attività difensive ivi svolte nell’interesse della parte ammessa al beneficio).
Solo la violazione delle disposizioni poste dal D.P.R. n. 115 del 2002 per la corretta liquidazione delle competenze in favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato può essere posta a fondamento del ricorso del difensore, che non ha quindi motivo di dolersi dell’eventuale differenza tra l’importo liquidatogli e quello invece posto a carico del soccombente (essendo invece quest’ultimo l’unico ad essere effettivamente pregiudicato da tale differenza).
I motivi devono essere rigettati.
Il motivo è infondato essendo evidente come la sua formulazione appaia rivolta a sollecitare una rideterminazione del carico delle spese di lite in ragione dell’auspicato, ma non intervenuto, accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, non essendo quindi rivolto a censurare la corretta applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c., ma piuttosto a rivalutare la stessa ricorrenza della condizione di soccombenza, alla luce della necessità di rivedere la stessa fondatezza dell’opposizione a suo tempo proposta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020
***
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. (Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 14/10/2014)
FONTI
CED Cassazione, 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30007-2014 proposto da:
C.F.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CARTEI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 14/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
PREMESSO CHE:
L’avvocato C.F.M. ha proposto opposizione, D.P.R. n. 115 del 2202, ex art. 170 e D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 15, contro il decreto con cui il Tribunale di Livorno le ha liquidato i compensi quale difensore di Ci.Ni., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, affermandone l’erroneità in quanto è stata liquidata la metà della somma cui è stata condannata nel processo la parte soccombente, con ciò violando la disciplina vigente come interpretata dalle sezioni penali di questa Corte e dalla pronuncia n. 270/2012 della Corte costituzionale, e non è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate.
Il Tribunale di Livorno – con ordinanza 14 ottobre 2014, n. 14436 – ha disposto il pagamento delle spese vive documentate e per il resto ha confermato il decreto.
Contro l’ordinanza ricorre in cassazione C.F.M..
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, con cui chiede il rigetto del ricorso perchè inammissibile e/o infondato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO CHE:
Il denunciato vizio di omessa pronuncia non sussiste. Il Tribunale (p. 5 del provvedimento impugnato) ha dichiarato l’infondatezza della opposizione “là dove ha lamentato l’erronea quantificazione dei compensi liquidati. Gli stessi – afferma il Tribunale – sono stati correttamente liquidati a favore dell’avv. C. (..) in conformità al D.M. n. 140 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis”.
Il motivo non può essere accolto. Nell’articolata e ragionata motivazione del provvedimento il Tribunale, premessa la mancanza di una norma espressa che regoli il rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha applicato la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, secondo cui “gli importi spettanti al difensore (..) sono ridotti della metà”, dopo aver considerato sia le pronunzie del giudice delle leggi sia l’orientamento della 6 sezione penale.
Il Collegio condivide la conclusione del giudice di merito. Il giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità del citato art. 130 per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost., si è limitato, nell’escludere l’asserito contrasto fra la disposizione legislativa e l’art. 53 Cost., a richiamare l’orientamento della 6 sezione penale di questa Corte, per concludere che “nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi – giustificata (..) dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce – tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario (Corte cost., ordinanza 270/2012). Quanto all’orientamento della 6 sezione penale, sviluppato dalla pronuncia 46537/2011, esso sì afferma che “la somma che l’imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore”, ma tale affermazione viene fatta sulla base di una analisi del rapporto imputato-parte civile-Stato-difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale (e va sottolineato che il D.P.R. n. 115 del 2002 detta disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale particolari rispetto a quelle dedicate al processo amministrativo, contabile e tributario, disposizioni che ne 2012 non prevedevano, come oggi prescrive l’art. 106-bis, alcuna riduzione degli importi spettanti al difensore). Inoltre, la citata pronuncia n. 46537 impone la contestualità della condanna in favore dello Stato e della liquidazione in favore del difensore: la necessaria coincidenza tra le spese di difesa (che vanno parametrate ai sensi dell’art. 82 e quindi con l’allora unico limite per il processo penale dei valori medi delle tariffe professionali) e la rifusione in favore del difensore è ottenuta – afferma la pronuncia – con la liquidazione delle spese al difensore direttamente con la sentenza di condanna dell’imputato; il giudice del processo penale, pertanto, nel medesimo dispositivo deve provvedere all’indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell’imputato, contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile.
Ciò significa, venendo al motivo di ricorso avanzato dalla ricorrente, che la medesima non può, richiamando la giurisprudenza penale, invocare – nel nome della coincidenza tra spese riconosciute allo Stato e spese liquidate al difensore – l’applicazione di una somma uguale a quella che è stata attribuita dal giudice del processo senza applicare la dimidiazione prescritta dall’art. 130, perchè al più, richiamando quella giurisprudenza, può apparire illegittima la condanna alle spese in favore dello Stato contenuta nella sentenza che ha definito il processo (rispetto alla quale, comunque, è privo di legittimazione l’avvocato, che ha accettato la difesa secondo il sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, potendo essere fatta valere dalla parte soccombente condannata al pagamento delle spese), ma non quella operata dal giudice con il decreto di liquidazione, che ha applicato il disposto di una disposizione, considerata legittima dal giudice delle leggi, che impone che gli importi spettanti al difensore (nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari) siano ridotti della metà. Nè a diversa conclusione, ad avviso del Collegio, conduce la pronuncia della 6 sezione civile di questa Corte che ha ravvisato nell’orientamento della 6 sezione penale l’espressione di un principio generale che si presta a trovare applicazione anche nel settore dei giudizi civili (Cass. 18167/2016, ripresa da Cass. 21611/2017). Da un lato la pronuncia non considera, come si è detto, le peculiarità del sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato; dall’altro lato, estendendo il principio della coincidenza degli importi al sistema del processo civile, che distingue tra condanna alle spese in favore dello Stato e decreto di liquidazione in favore del difensore, indipendentemente dall’applicazione della dimidiazione dei compensi, porta a una sostanziale disapplicazione dell’art. 130.
Quanto al profilo – che non entra, come si è visto, direttamente in gioco in questa causa – se il giudice del processo, quando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, condanna il soccombente alle spese processuali a favore della parte ammessa disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, debba seguire i criteri di cui agli artt. 82 e 130 ovvero debba seguire gli ordinari parametri, la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria. Non si vede infatti perchè nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri partì soccombenti, mentre d’altro canto – come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata – la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità.
Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27653-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DEKKA OREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;
– ricorrente –
contro
L.C., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MONZA, depositato il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L.C. ha promosso un procedimento ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.. Espletata la ctu, il giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha omologato l’accertamento dichiarando che il ricorrente “si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, a decorrere dal 15 settembre 2015”. Il giudice, nel medesimo decreto, ha poi provveduto sulle spese, ponendo quelle di consulenza tecnica a carico dell’INPS. Quanto alle spese legali, poichè il ricorrente, vincitore del giudizio, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice ha condannato la parte soccombente (INPS) a rifonderle all’Erario. Nel decreto di omologa le spese sono state quantificate in favore dell’erario in misura di 1.400,00 Euro oltre accessori, mentre nel decreto di pagamento degli onorari al difensore del L. erano state quantificate in 700,00 Euro oltre accessori.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro la parte del decreto di omologa che lo condanna al pagamento delle spese in misura di 1.400,00 Euro.
l’Istituto denunzia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, 100, 131 e 133, e dell’art. 2041 c.c. per essere stato condannato al pagamento in tale misura, a fronte di un decreto di liquidazione in misura di 700,00 Euro, pari quindi alla metà.
In tal modo, lo Stato che per decreto del giudice ha versato al difensore 700,00 Euro oltre accessori, ne incassa 1.400,00 dalla parte soccombente (INPS).
L’Istituto ricorrente per cassazione chiede che sia ribadito il principio di diritto, affermato da Cass. 16 settembre 2016, n. 18167, per il quale le spese legali che il giudice pone a carico della parte soccombente ed a favore dello Stato (in luogo della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) devono corrispondere alle spese liquidate in favore del difensore della parte non abbiente.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La disciplina dettata del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità” (art. 82). L’art. 130 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) aggiunge: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Quindi, onorario e spese del difensore della persona ammessa a al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con decreto del giudice, in base alla tariffa professionale vigente, non possono essere superiori ai valori medi e devono essere ridotti alla metà. Contro il decreto di pagamento è ammessa opposizione (art. 84).
L’art. 133 si occupa del caso in cui la parte ammessa al patrocinio vinca la causa e quindi abbia diritto alla rifusione delle spese legali da parte del soccombente. La norma prevede: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
In effetti, come rileva l’INPS nel suo ricorso, la Corte di cassazione con la sentenza della seconda sezione civile 16 settembre 2016, n. 18167, richiamando i principi espressi dalla Cassazione penale nella sentenza 46537/2011, aveva affermato il principio per cui “Qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi del medesimo decreto, art. 82 e 103, al fine di evitare che eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale”.
Ma la Corte con la sentenza 11 settembre 2018, n. 22017, sempre della seconda sezione, ha modificato il suo orientamento.
Nella motivazione si premette che le affermazioni di principio fatte dalla Cassazione penale si basano su di un’analisi del rapporto “imputato – parte civile – Stato – difensore” che è specifico del sistema processuale penale, nel cui ambito, peraltro, la liquidazione dei compensi e la condanna alla rifusione delle spese devono avvenire nel medesimo dispositivo, cosa che non vale per il civile. Non è corretto, pertanto, estendere meccanicamente ciò che si afferma in ambito penalistico al sistema civilistico.
Quanto poi al punto decisivo costituito dal vantaggio che lo Stato avrebbe nel percepire compensi doppi rispetto a quelli spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la decisione del 2018 ha giustamente rilevato: “la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità“.
In tal modo, peraltro, si evita quella che sarebbe una grave incongruenza all’interno del sistema costituita dal fatto che la parte che perde verrebbe condannata al pagamento delle metà delle spese per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso pertanto deve essere respinto. Nulla sulle spese perchè la controparte è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13819-2016 proposto da:
S.A., quale difensore di se stesso, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 30 marzo 2016 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. S.A. avverso il decreto di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 per l’attività professionale svolta a favore di Z.A., quale soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
A fronte della richiesta dell’opponente, che si doleva del fatto che il decreto avesse riconosciuto in suo favore una somma inferiore rispetto a quella che era stata posta a carico della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all’esito del giudizio nel quale il ricorrente aveva prestato la sua attività, la Corte d’Appello riteneva che si trattava di doglianza che poteva al più essere sollevata da parte del soggetto che era stato condannato al rimborso delle spese nel giudizio di cognizione, che poteva appunto evidenziare l’ingiustificato arricchimento che veniva a determinarsi in favore dello Stato. Nella fattispecie inoltre la liquidazione effettuata dal giudice di merito nel decreto opposto risultava rispettosa dei limiti tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, essendo corretta la decisione di avvalersi dei valori medi per la fase istruttoria e dei valori minimi per la fase decisionale, sostanzialmente corrispondente e ripetitiva dell’attività già svolta per la fase di studio ed introduttiva.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso S.A. sulla base di un motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa fase.
Il motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 13 e 133.
Si evidenzia che la Corte d’Appello di Venezia Sezione Lavoro, nel decidere nel merito la controversia nell’ambito della quale il ricorrente aveva prestato la sua attività nell’interesse di Z.A., soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva disposto la compensazione per la metà delle spese del doppio grado, condannando la controparte al pagamento della residua parte, quantificata in Euro 4.875,00 per il primo grado, ed in Euro 2.327,50 per le spese del giudizio di appello, per la fase che aveva preceduto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed in Euro 4.490,00 (così corretta a seguito di apposita procedura, la somma erroneamente indicata in un primo momento) per la fase successiva (fase istruttoria e decisionale) prevedendo in particolare che quest’ultima cifra dovesse essere versata in favore dello Stato. Viceversa la stessa Corte nel provvedere sulla richiesta di liquidazione del ricorrente, con decreto del 5/11/2015 aveva riconosciuto allo S. la minor somma di Euro 1.337,50 oltre accessori di legge, decisione questa confermata dall’ordinanza impugnata.
Deduce il ricorrente che le norme di cui alla rubrica del motivo sono state interpretate dalla Cassazione penale di questa Corte nel senso che debba esservi coincidenza tra quanto liquidato in favore dello Stato nell’ambito del giudizio nel corso del quale risulta essere prestata l’attività defensionale in favore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e quanto invece attribuito allo stesso difensore in sede di successiva liquidazione.
Opinare diversamente creerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione, non apparendo comprensibile la ragione per la quale debba assicurarsi una locupletazione in favore dello Stato.
Peraltro la soluzione della Cassazione penale ha trovato il conforto anche nella giurisprudenza costituzionale, atteso che Corte Cost. n. 270/2012 ha opinato nel senso della coincidenza tra le due liquidazioni.
Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.
A tal fine deve richiamarsi, come appunto ricordato dal ricorrente, quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 270/2012, laddove al fine di escludere i dubbi di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 sollevati dalle ordinanze di rimessione, ha escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva puntualizzato che la somma che, ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 133, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. 6 penale, 8 novembre 2011, n. 46537).
A tal riguardo deve altresì evidenziarsi che anche la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte ha aderito a tale opinione, essendosi affermato che, qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. n. 18167/2016).
Ritiene il Collegio di dover dare continuità a tale orientamento, con la conseguenza che il motivo debba essere accolto con la cassazione dell’ordinanza impugnata.
Tuttavia, non apparendo necessario compiere ulteriori accertamenti, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.365,00, in conformità di quanto liquidato dalla Corte d’Appello all’esito del processo che ha visto protagonista la parte ammessa al beneficio, oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio e della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.365,00, oltre accessori di legge;
Condanna il Ministero al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida per il giudizio di opposizione in Euro 1.200,00, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017
***
Qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 05/06/2013)
FONTI
CED Cassazione, 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18988/2013 proposto da:
S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 989, presso la residenza di RAFFAELE LO BUE, rappresentato e difeso dall’avvocato da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 183/2013 RGACC della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 3/06/2013, depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Svolgimento del processo
Con decreto del 12 dicembre 2012, la Corte di Appello di Catanzaro liquidava in favore dell’Avv. S.A. la somma di Euro 1.000,00 per l’attività difensiva prestata, nel giudizio civile n. 241/2005 R.G., a favore di C.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso suddetto decreto, l’Avv. S. proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, lamentando che la Corte avrebbe dimezzato due volte, in applicazione dell’art 130 del Decreto presidenziale, le competenze a lui spettanti ex artt. 82 e segg..
Il giudice calabrese rigettava l’opposizione con l’ordinanza del 3 giugno 2013, depositata in data 5 giugno 2013, avverso la quale l’Avv. S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, notificato a mezzo posta il 24 giugno 2013, articolando due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2041 c.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 130 e 133.
Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa pronuncia del giudice su alcune delle eccezioni articolate nel precedente grado di giudizio.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA non ha svolto difese in questa sede.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Il ricorrente, deducendo con i due motivi la violazione delle norme del Testo Unico sulle spese di giustizia e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, contesta l’ingiusto dimezzamento da parte della Corte di Appello di Catanzaro dell’entità dei compensi a lui spettanti per l’attività di gratuito patrocinio resa in un giudizio civile, in quanto le somme indicate nella sentenza conclusiva del giudizio presupposto, poi ridotte ulteriormente a seguito dell’istanza di liquidazione, erano state già calcolate in misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130. Il ricorrente deduce pertanto che la scelta del giudice sarebbe contraria alla ratio delle norme di settore e ai principi generali dell’ordinamento, perchè da essa deriverebbe un ingiustificato arricchimento dello Stato a discapito dell’originario soccombente, tenuto unicamente al rimborso delle somme anticipate dall’erario ai sensi degli artt. 131 segg. del T.U.. A tal proposito, egli afferma peraltro di aver prospettato in sede d’opposizione alcune dirimenti eccezioni, che il giudice de quo avrebbe respinto senza articolare specifica motivazione.
Tali censure, che per la loro stretta connessione si prestano a uno scrutinio congiunto, appaiono fondate.
Questa Corte, con la sentenza n. 46537 del 2011, ha sancito il principio secondo cui, qualora nell’ambito di un giudizio penale l’imputato sia condannato anche alla refusione delle spese giudiziali in favore della parte civile ammessa a gratuito patrocinio, la quantificazione degli onorari e delle spese ex artt. 82 segg. T.U., liquidate dallo Stato in favore del difensore del non abbiente, deve necessariamente corrispondere alla quantificazione delle somme dovute dall’imputato allo Stato anticipatario, secondo il meccanismo di cui all’art. 110 T.U..
A fondamento delle proprie conclusioni, la Corte richiama l’operare sinergico del divieto dell’ingiustificato arricchimento e del divieto di ingiustificati danni erariali, i quali impongono all’interprete la soluzione della netta corrispondenza fra quanto dovuto dall’imputato allo Stato e quanto dovuto dallo Stato al gratuito patrocinatore, al fine di evitare che l’eventuale divario tra le somme possa costituire occasione di ingiusto profitto o di danno per le casse statali: Allo stesso tempo, essa esclude che la validità della soluzione ermeneutica appena esposta possa essere pregiudicata dalle ricostruzioni di chi include tra le conseguenze negative dell’equazione imposta dal Giudice di legittimità anche quella di far beneficiare l’imputato dello stato di povertà del danneggiato, permettendogli di rimborsare le spese giudiziali in misura ridotta rispetto a quelle normalmente versate per la difesa dell’abbiente, perchè limitate, ai sensi dell’art. 82 T.U., al valore medio delle singole voci tariffarie. Del resto, tali contestazioni, pur rilevando un dato oggettivo, ossia la minore entità delle somme rimborsate, vi riconoscono un’iniqua attenuazione del regime sanzionatorio imposto al condannato, disconoscendo così la vera ratio dell’istituto della rifusione delle spese legali, il quale mira unicamente a tenere indenne la controparte dei costi sostenuti per la propria difesa, senza perseguire ulteriori finalità di stampo punitivo.
Il principio espresso dalla Corte, poi confermato dall’ordinanza n. 270/2012 del Giudice delle leggi, traendo fondamento da principi generali, e non settoriali, dell’ordinamento, risulta connotato da una notevole vis espansiva, in virtù della quale esso si presta a trovare applicazione non solo nell’ambito del processo penale, ma anche nel settore più ampio dei giudizi civili. Pertanto, anche nel caso di specie, nel quale è risultata soccombente la parte non ammessa al gratuito patrocinio, il giudice adito ex art. 170 T.U. avrebbe dovuto liquidare i compensi spettanti al ricorrente in misura non inferiore rispetto a quella delle spese giudiziali calcolate al termine del giudizio presupposto. Difatti, la Corte di Appello di Catanzaro, pur rilevata l’assenza di circostanze tali da far ritenere già applicato il dimezzamento obbligatorio, avrebbe dovuto comunque attenersi alla pregressa liquidazione delle spese giudiziali, peraltro non impugnata e passata in giudicato, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dello Stato a discapito del soccombente, tenuto altrimenti a versare somme superiori rispetto a quelle effettivamente dovute al gratuito patrocinatore ai sensi degli artt. 82 e 130 T.U..
Pertanto, ribadito in sede civile il principio secondo cui il giudice è tenuto a quantificare in misura eguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e le somme dovute dallo Stato al difensore ex artt. 82 e 130 T.U., appare opportuna la scelta di procedere in via camerale ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., potendosi rilevare la manifesta fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la quale l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016
***
In tema di patrocinio dei non abbienti, l’importo che l’imputato, condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio, è tenuto a corrispondere allo Stato “ex” art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve coincidere con la somma che il giudice liquida in favore del difensore della parte civile stessa “ex” art. 82 del d.P.R. cit., dovendo quindi anche tale liquidazione essere contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Belluno, 16 ottobre 2008)
FONTI
CED Cassazione, 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo – Consigliere
Dott. CORTESE Arturo – Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) F.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 828/2008 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del 16/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. R.G. Russo per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricordato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deduce che la liquidazione come in concreto disposta dal GIP potrebbe profilare un indebito arricchimento della medesima parte civile, e un corrispondente danno dell’imputato, in ragione della possibilità che questa ottenga una duplicazione della liquidazione dei compensi al proprio difensore. Richiama giurisprudenza di merito a sostegno della tesi che il GIP avrebbe dovuto limitarsi ad affermare il diritto della parte civile all’an debeatur, in ordine alla rifusione delle spese legali, con rinvio per la quantificazione alla procedura prevista nell’ambito della disciplina speciale del patrocinio a spese pubbliche. Chiede l’annullamento della relativa statuizione, senza o con rinvio.
2.1 Il procuratore generale in sede, richiamato l’insegnamento di Sez. 4 sent. 26663/2008 e dedotto dell’autonomia delle due liquidazioni, quella ex art. 541 c.p.p., e quella D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1 Va premesso che sussiste l’interesse del ricorrente all’impugnazione, non già in relazione al paventato eventuale arricchimento indebito della parte civile, ma perchè, in quanto debitore di somma da corrispondere con riferimento alle spese di difesa sostenute nel processo dalla parte civile, egli ha diritto a conoscere l’esatta indicazione del suo unico creditore (nel caso di specie lo Stato e non direttamente la parte privata, trattandosi effettivamente di parte civile che risulta dai verbali di udienza essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
3.2 La fattispecie all’esame della Corte di legittimità è quella del processo penale nel quale la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l’imputato sia stato condannato anche alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla medesima parte civile.
Tale fattispecie apparentemente vede il contrasto tra due discipline.
Infatti, l’art. 541 c.p.p., comma 1, prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”. La quantificazione di tali spese avviene secondo le norme ed i criteri generali della tariffa professionale penale ed è appunto uno dei capi della sentenza, suscettibile di autonoma impugnazione.
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevede invece che il compenso al difensore della parte ammessa sia liquidato dal giudice che ha proceduto con apposito decreto di pagamento (art. 82, comma 1 t.u.s.g. e per quanto pertinente al nostro caso), al termine di ciascuna fase o grado del processo (art. 83, comma 2). La quantificazione del compenso avviene sempre con l’osservanza delle tariffe professionali, ma incontra il limite indefettibile del valore medio delle singole voci (art. 82, comma 1).
Quando appunto ammessa al patrocinio a spese pubbliche è la parte civile, l’art. 110, comma 3 t.u.s.g., con disposizione specifica, prescrive che “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”.
E’ evidente pertanto che in questo tipo di fattispecie vi è la sovrapposizione di tre “relazioni”: quella tra l’imputato e la parte civile, quella tra l’imputato e lo Stato, quella tra lo Stato e la parte civile.
3.3 Nei casi come quello che ci occupa, si pone pertanto innanzitutto il quesito se la somma che il giudice con la sentenza deve porre a carico dell’imputato per la rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile vincitrice, ma che vedono come destinatario lo Stato e non la parte privata, debba o meno coincidere con quella, a carico dello Stato, che lo stesso giudice deve liquidare al difensore della parte civile, con il decreto ex art. 82 t.u.s.g..
In altri termini, il quesito è se vi sia (vi debba essere) coincidenza tra la quantificazione delle spese legali che l’imputato è condannato a corrispondere in favore dello Stato/Erario e la quantificazione della somma dal medesimo Stato/Erario liquidata al difensore della parte civile, con una sostanziale sovrapposizione tra le distinte relazioni imputato – parte civile, Stato – parte civile ammessa al patrocinio pubblico, imputato – Stato.
Come corollario, si pone l’ulteriore quesito se il regime delle eventuali impugnazioni sul punto della quantificazione della somma che l’imputato è condannato a pagare in favore dello Stato (e che lo Stato liquida al difensore della parte civile) sia poi quello ordinario previsto dall’art. 574 c.p.p. e ss., o quello speciale disciplinato dagli artt. 84 e 170 t.u.s.g..
3.4 La questione proposta ha due autonomi ambiti di rilevanza, uno sostanziale e l’altro procedimentale.
3.4.1 Nel merito, a sostegno della soluzione positiva (tesi della necessaria coincidenza tra la somma che l’imputato deve corrispondere allo Stato e quella che lo Stato deve poi corrispondere al difensore di parte civile) può richiamarsi l’operare sinergico sia del generale principio di divieto dell’ingiustificato arricchimento (lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore di parte civile, più di quanto poi è tenuto a corrispondere al medesimo professionista proprio per quella specifica prestazione), sia di quello altrettanto generale dell’evitare ingiustificati danni erariali (che si verificherebbero ove lo stato – si noti : per la medesima causale – ricevesse dall’imputato, in ragione della sua soccombenza civile, somma inferiore a quella che poi corrisponde al difensore della parte civile).
A sostegno della risposta negativa potrebbe osservarsi che altrimenti l’imputato beneficerebbe paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha danneggiato, trovandosi a rimborsare spese legali che, in ragione del limite quantitativo imposto dall’art. 82 t.u.s.g., sarebbero senz’altro inferiori a quelle da lui dovute se il danneggiato fosse abbiente e, quindi, fossero state liquidate senza il limite del valore medio delle voci tariffarie. Deve tuttavia osservarsi che quest’ultimo rilievo, se coglie un aspetto certo singolare della questione (- di fatto l’imputato trae personale vantaggio economico dalla non abbienza di colui che ha danneggiato), tuttavia presuppone che si attribuisca alla rifusione delle spese di lite tra le parti un contenuto in qualche modo anche “sanzionatorio”.
Ciò, dal punto di vista sistematico, è certo improprio, in quanto presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere appunto indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle (esulando del tutto alcuna finalità “punitiva” del tipo di quella ora prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c.).
Quindi, se le spese di difesa sostenute vanno parametrate ai sensi del richiamato art. 82 – come il difensore di parte civile ha accettato che fosse, assumendo la difesa nel sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato – l’integrale, e definitiva, rifusione coincide con la somma liquidata secondo i parametri indicati dall’art. 82.
Va pure ricordato, infatti, che mentre nel caso di liquidazione a spese pubbliche della difesa d’ufficio, quando venisse poi comprovata la possibilità di un’utile escussione del patrimonio dell’imputato il difensore può chiedere all’assistito la corresponsione di somme ulteriori, relative alla differenza in aumento tra quelle “calmierate” e quelle possibili secondo le norme tariffarie, invece nel sistema del patrocinio a spese dello Stato nulla può più essere chiesto dal difensore alla parte assistita (ex art. 85 stesso testo unico), perchè l’eventuale venir meno dello stato di non abbienza rileva solo nel rapporto tra la parte ammessa al patrocinio a spese pubbliche e l’Erario (art. 111 t.u.s.g.).
3.4.1.1 E’ poi vero che il rapporto imputato-parte civile, quanto alla rifusione delle spese, ha comunque una sua potenziale autonomia (ai sensi dell’art. 541 c.p.p.) rispetto all’altro (Stato/difensore della parte civile ammessa), giacché il giudice, ricorrendone le circostanze di merito e legittimità, potrebbe compensare tali spese (soluzione ben possibile anche quando la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
In tale evenienza, quindi, ed ovviamente a maggior ragione anche nel caso dell’assoluzione dell’imputato, nulla sarebbe dovuto dall’imputato allo Stato, mentre il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche manterrebbe sempre il diritto, nei confronti dell’Erario, alla liquidazione dei propri compensi, secondo i consueti criteri ex art. 82 cit.. Tale assetto consegue al fatto che la difesa tecnica della parte danneggiata nel processo penale ha presupposti, contenuti e disciplina distinti, rispetto a quella del soggetto non abbiente che agisca nel processo civile: basti pensare all’irrilevanza del presupposto della non manifesta infondatezza delle ragioni (art. 74, comma 2 t.u., rispetto al comma 1) ed alla possibilità di impugnare nonostante la soccombenza (art. 120 t.u.). In definitiva, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione del compenso anche nel caso di mancato accoglimento delle domande civilistiche, con il solo limite, comune a tutti i casi di ammissione al patrocinio a spese pubbliche nel processo penale, dell’impugnazione dichiarata inammissibile, ex art. 106, comma 1 t.u. (per tutte, Sez. 4, sent. 42508/2009).
Ma è appunto esclusivamente in tali due casi – assoluzione e compensazione – che le discipline dell’art. 541 c.p.p., artt. 82 e 110 t.u.s.g. mantengono la propria autonomia.
Quando invece la sentenza penale contiene il riconoscimento della responsabilità dell’imputato anche ai fini civili e la sua condanna alla rifusione delle spese legali, tale autonomia vien meno, trovando applicazione esclusivamente la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, normativa successiva, speciale e specifica rispetto a quella dell’art. 541 c.p.p..
In altri termini, in realtà non vi è una sovrapposizione di norme non coordinate (situazione che pur imporrebbe la ricerca di soluzione interpretativa sistematica), bensì l’operare in concreto del generale principio di specialità tra diverse discipline che riguardino la medesima fattispecie.
In tal senso non può essere condivisa la giurisprudenza della Quarta sezione di questa Corte sul punto, secondo la quale i provvedimenti ex art. 541 ed ex art. 82 sarebbero sempre “distinti ed entrambi necessari”, “rispondendo a finalità e ratio legis assolutamente differenti tra loro”, sicchè la “difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazioni” e gli “inconvenienti” conseguenti dovrebbero essere evitati solo “riconoscendo l’autonomia delle due liquidazioni” (per tutte, Sentenze 42844/08 e 26663/08). Appare invero francamente assorbente l’osservazione che non si comprende quale spazio avrebbe, nella fattispecie esaminata ed alla luce delle considerazioni sistematiche prima svolte, la statuizione relativa all’art. 541 c.p.p. (intesa come condanna diretta dell’imputato in favore della parte civile), risultando così in realtà solo inutiliter data. Perchè, giova ripeterlo, quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ordine alla disciplina della rifusione delle spese legale non residua alcun rapporto diretto tra l’imputato soccombente e la parte civile, perché l’unico rapporto di quest’ultima – e del suo difensore – è solo con lo Stato.
Sicché porre a carico dell’imputato la liquidazione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato costituisce solo un errore di diritto e realizza un vizio di violazione di legge.
3.4.1.2 Deve pertanto privilegiarsi la soluzione della coincidenza tra le somme, per cui la prima conclusione è l’affermazione del principio di diritto che, quando il giudice del processo penale condanna l’imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l’imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. 3.4.2 Del resto, passando agli aspetti in rito, la necessaria coincidenza tra le somme relative al rapporto imputato – Stato ed a quello Stato – parte civile si ottiene agevolmente liquidando direttamente con la sentenza al difensore le spese di difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio.
Il giudice del processo penale – che ben sa che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese pubbliche – quando condanna l’imputato anche al pagamento delle spese di difesa sostenute da tale parte, nel medesimo dispositivo deve provvedere all’indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell’imputato, quantificandolo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma.
Si tratta, in realtà, non tanto o non solo soluzione sistematica quanto, giova precisarlo, la conseguenza immediata dell’applicazione concreta della specialità della disciplina dell’art. 110 t.u.s.g. rispetto all’art. 541 c.p.p., ovviamente sul punto della sola quantificazione – rimanendo l’an debeatur disciplinato integralmente e solo dall’art. 541 c.p.p. -.
Il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche, pertanto, deve presentare al momento delle proprie conclusioni, all’esito della discussione, la propria nota spese già conforme alle regole dell’art. 82.
Del resto, per quanto ormai più volte evidenziato, una sua nota spese che prescindesse del tutto da quelle regole e da quei criteri non avrebbe alcuna efficacia nè troverebbe senso sistematico alcuno, posto che il suo rapporto è, quanto ai propri onorari ed alle proprie spese e dal momento in cui assume la difesa di persona danneggiata ammessa al patrocinio a spese pubbliche, solamente con lo Stato.
E, in ogni caso, la liquidazione del giudice procedente non potrebbe che vincolarsi a quei parametri, quali che fossero le entità delle singole voci sollecitate dalla nota, in esubero o non conformità ai criteri di cui all’art. 82.
Conseguenza sistematica ulteriore è che le impugnazioni relative all’an debeatur sono disciplinate dal codice di rito, come tutte quelle relative ai singoli punti della decisione, mentre quelle relative al quantum debeatur sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, (che prevedono la partecipazione di tutte le parti processuali interessate), posto che il difensore ha diritto alla liquidazione al termine di ciascuna fase o grado del processo, sicchè risulta sistematicamente illegittima l’eventuale differimento dell’efficacia delle singole liquidazioni al momento unico dell’eventuale passaggio in giudicato della decisione.
3.4.2.1 Deve pertanto affermarsi l’ulteriore principio di diritto che quando il giudice del processo penale condanna l’imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, nel dispositivo deve contestualmente sia disporre che il pagamento avvenga in favore dello Stato che procedere alla liquidazione in favore del difensore.
– l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di difesa sostenute dalla parte civile direttamente alla stessa;
– il disporre, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. L), che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
– il disporre e confermare la liquidazione della somma, come determinata dal GIP, in favore del difensore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, condanna che dispone avvenga in favore dello Stato. Conferma la liquidazione in favore del difensore di parte civile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 110.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011
***
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile deve coincidere con quella disposta in favore del difensore della parte civile ai sensi dell’art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicchè il mancato inserimento di tale seconda statuizione, direttamente correlata e vincolata alla prima, nel corpo del dispositivo, integra un mero errore materiale omissivo, emendabile con la procedura di correzione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 15/12/2017)
FONTI
CED Cassazione, 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. VIGNA Maria S. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.L., nato il (OMISSIS), parte civile costituita;
nel processo contro:
F.F., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/12/2017 della CORTE d’APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost., Dott. Gaeta Pietro, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui omette l’assegnazione alla parte civile delle somme liquidate a beneficio dello Stato anticipatario;
sentito il difensore.
Svolgimento del processo
Si assume, più precisamente, che, comportando la condanna dell’imputato alle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa a gratuito patrocinio che lo Stato sia tenuto a corrispondere anticipatamente al patrono di tale parte “quanto liquidato proprio per quella specifica prestazione, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’imputato”, la Corte territoriale sarebbe appunto incorsa in errore di diritto – e, in ogni caso, in vizio di motivazione – non avendo provveduto, dopo la corretta indicazione dello “Stato come creditore del pagamento a carico dell’imputato”, alla contestuale “liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile”, così come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: solo in tal modo, infatti, “con un’esatta applicazione ed esplicitazione anche letterale del dettato normativo di cui al citato art. 110, comma 3”, sarebbe possibile garantire al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato “di agire, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, direttamente nei confronti dello Stato “anticipatario” al fine di ottenere il pagamento dei compensi e delle spese spettanti per l’attività di patrocinio svolta”.
Motivi della decisione
Dunque, secondo detta pronuncia, ove si sia al cospetto di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora il giudizio si concluda con l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, la condanna di quest’ultimo a rifondere le spese sostenute nel grado dall’anzidetta parte civile;
– con pagamento da effettuarsi a beneficio dell’Erario, giusta il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3, che deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 541 codice di rito – deve essere pari, nel quantum, all’ammontare della somma posta a carico dello stesso Erario, a titolo di onorari e competenze liquidati in favore del legale che ha espletato il proprio mandato all’interno del rapporto di patrocinio gratuito, nell’interesse della parte civile medesima. Ciò in quanto l’autonomia dei rapporti imputato-parte civile, cui si raccorda quello fra Stato e imputato, e Stato-difensore della parte civile ammessa a patrocinio:
– quale si manifesta indiscutibilmente nelle ipotesi, entrambe estranee al caso di specie, di assoluzione dell’imputato e di disposta compensazione (totale o parziale che sia) delle spese processuali fra le parti private, in ciascuna delle quali rimane comunque ferma la legittima pretesa del legale della parte civile ammessa a patrocinio di ottenere dallo Stato la liquidazione per l’opera professionale prestata – è destinata a venire meno appunto nell’eventualità, conforme a quella in esame, di condanna dell’imputato, senza compensazione delle spese fra le parti private: in un caso siffatto, invero, “in ordine alla disciplina delle spese legali, non residua alcun rapporto diretto tra l’imputato soccombente e la parte civile, perchè l’unico rapporto di quest’ultima – e del suo difensore – è solo con lo Stato”. Opinare diversamente, infatti, significherebbe, a seconda dei casi, esporsi alla possibilità che lo Stato riceva dall’imputato, per l’attività del difensore di parte civile, una somma maggiore di quella corrisposta al medesimo professionista per la medesima prestazione, ovvero a quella, esattamente contraria, che lo Stato subisca un danno, ottenendo dall’imputato – sempre per l’identica causale – una somma inferiore a quella da esso stesso riconosciuta al difensore della parte civile.
In altri termini, in ambedue i casi si verrebbe a determinare, a fronte dell’identità della prestazione fornita dal legale della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una situazione, del tutto gratuita, di sostanziale ingiustizia, destinata a risolversi in una violazione del principio di ordine generale che sancisce il divieto di ingiustificato arricchimento, ora a beneficio dello Stato, ora a beneficio dell’imputato, in tale ultima ipotesi con contestuale produzione di un altrettanto ingiustificato danno erariale. Non senza aggiungersi che non ha portata dirimente l’osservazione di segno opposto – per cui l’imputato verrebbe a beneficiare “paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha danneggiato”, rimborsando, per effetto del limite quantitativo imposto dall’art. 82 T.U. del 2002, somme senz’altro inferiori a quelle da lui dovute se il danneggiato fosse stato abbiente – giacchè la stessa risulta informata ad un profilo di tipo sanzionatorio, che è del tutto estraneo alle finalità che sono proprie della rifusione delle spese di lite, deputate unicamente a tenere indenne la parte dalle spese sostenute a cagione del processo che l’ha vista vittoriosa, al di fuori di qualsivoglia intento di natura “punitiva”.
Onde cogliere la portata dell’affermazione, occorre tenere nella debita considerazione che il caso da cui muove la sentenza del 2011 è per certo diverso da quello che qui si affronta, avendo la stessa dovuto rimediare al chiaro errore di diritto commesso dalla sentenza d’appello – impugnata dallo stesso imputato, per tema di una duplicazione dei provvedimenti di liquidazione a beneficio della parte civile – nella parte in cui aveva disposto il pagamento delle spese del grado da parte dell’imputato direttamente alla parte civile, nonostante l’ammissione al patrocinio gratuito di quest’ultima.
Nella presente fattispecie, per contro, la sentenza di secondo grado, nell’accogliere il motivo d’appello avverso la compensazione parziale delle spese processuali disposta dal primo giudice, ha determinato in Euro 2.400,00 l’ammontare delle spese anzidette, sostenute dalla parte civile nel corso del primo grado di giudizio, ed ha correttamente statuito che il relativo pagamento avvenga “in favore dello Stato anticipatario”: dunque, ciò che manca è unicamente la contestuale liquidazione di pari importo al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Conseguenza ulteriore e definitiva di siffatto discorso è che nella presente fattispecie non vi è un reale ed effettivo pregiudizio da rimuovere e, dunque, un interesse da tutelare, ma si è in presenza di una mera dimenticanza, alla quale l’interessato ben potrà porre agevolmente rimedio mediante la semplice attivazione della procedura di correzione di errore materiale innanzi alla competente Corte d’appello.
Discende da ciò la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui seguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p., nella misura di giustizia specificata in dispositivo quanto alla condanna a beneficio della Cassa delle Ammende, avuto riguardo alla specificità della presente vicenda ed alle ragioni sostanziali ad essa sottese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2019
***
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili. Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata sulla base del rilievo che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate e che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari, e non risultano addotte ragioni nuove e diverse da quelle già esaminate e disattese.
FONTI
Sito uff. Corte cost., 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
– Franco BILE Presidente
– Giovanni Maria FLICK Giudice
– Francesco AMIRANTE ”
– Ugo DE SIERVO ”
– Romano VACCARELLA ”
– Paolo MADDALENA ”
– Alfio FINOCCHIARO ”
– Alfonso QUARANTA ”
– Luigi MAZZELLA ”
– Gaetano SILVESTRI ”
– Sabino CASSESE ”
– Maria Rita SAULLE ”
– Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2005 dal Tribunale di Padova, sull’istanza proposta da P.L., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Tribunale di Padova, sull’istanza del difensore della parte intimata di un procedimento civile – ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) – volta alla liquidazione dell’onorario per l’attività prestata, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto all’onorario previsto per il difensore nel processo penale, per il quale la predetta riduzione non opera;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e l’infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, per un verso, la garanzia del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli, e, per l’altro, la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione; sicché, secondo l’Autorità intervenuta, contrapporre alle scelte operate in materia dal legislatore ordinario opzioni diverse comporterebbe la conseguenza di far assumere al giudizio costituzionale il carattere di una valutazione di opportunità, esorbitando dai limiti del predetto giudizio.
Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà, ove si tratti di processi civili, in quanto violerebbe l’art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nei processi penali, per i quali tale riduzione non è prevista;
che questa Corte, nell’esaminare identica questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha affermato che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale), e che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari (ordinanza n. 350 del 2005);
che il giudice rimettente, nel sollevare la questione, non ha addotto ragioni nuove e diverse da quelle in precedenza esaminate e disattese;
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Padova, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
Deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente.
Sito Il caso.it, 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Alfonso QUARANTA Presidente
– Franco GALLO Giudice
– Luigi MAZZELLA ”
– Gaetano SILVESTRI ”
– Sabino CASSESE ”
– Giuseppe TESAURO ”
– Paolo Maria NAPOLITANO ”
– Giuseppe FRIGO ”
– Alessandro CRISCUOLO ”
– Paolo GROSSI ”
– Giorgio LATTANZI ”
– Aldo CAROSI ”
– Marta CARTABIA ”
– Sergio MATTARELLA ”
– Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi dal Tribunale ordinario di Roma con quattro ordinanze del 21 settembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti gli atti di costituzione di A. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Giampiero Amorelli e Marco Annecchino per A. G. e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con quattro ordinanze di identico contenuto, tutte depositate in data 21 settembre 2011, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà»;
che il rimettente precisa di essere chiamato a giudicare sulla opposizione proposta da un avvocato – il quale ha difeso dei cittadini stranieri, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in procedimenti civili aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato politico – avverso i decreti con i quali, in relazione ai predetti giudizi, sono state liquidate le sue competenze;
che fra le lagnanze dell’opponente vi è quella legata all’avvenuta riduzione delle competenze nella misura della metà, operata ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002;
che il rimettente, ricostruite la modalità applicative della disposizione in questione – nel senso che il giudice, effettuata la liquidazione entro il limite degli importi medi previsti in funzione del valore della controversia, deve dimezzare l’importo così determinato ed attribuirlo al professionista solo nella misura così risultante -, ha, preliminarmente, escluso la tacita abrogazione della disposizione censurata per effetto della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede che «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (…) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale»;
che, in particolare, ad avviso del rimettente la previsione normativa sopravvenuta – resasi necessaria onde chiarire che il meccanismo di liberalizzazione delle tariffe, introdotto dallo stesso decreto-legge n. 223 del 2006, opera limitatamente ai rapporti di natura contrattuale fra professionista e cliente e non laddove la liquidazione intervenga ex officio – non esclude la operatività di altri meccanismi modificativi, fissati dalla legge, atti ad incidere sulla liquidazione tramite tariffa;
che – quanto alla rilevanza della questione nei giudizi a quibus – il rimettente precisa di essere chiamato a sindacare il provvedimento di liquidazione emesso sulla base della normativa censurata che egli, pertanto, è tenuto ad applicare in sede di gravame;
che, per ciò che concerne la non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la disposizione violerebbe diversi parametri costituzionali: vale a dire gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, comma primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti umani, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, espressivo del principio di eguaglianza, ritiene il Tribunale di Roma che molteplici siano i profili di illegittimità costituzionale riscontrabili nella disposizione censurata;
che, essa, infatti, determinerebbe una disparità di trattamento in funzione della natura, civile o penale, del processo in relazione al quale sono stati liquidati i compensi al professionista il cui cliente sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posto che l’abbattimento dei compensi liquidati dal giudice non opera in materia penale;
che – non ignaro che analoga questione di legittimità costituzionale già è stata in passato decisa da questa Corte, nel senso della sua manifesta infondatezza, sulla base della incomparabilità fra i due modelli processuali cui fa sfondo la diversità degli interessi coinvolti dai medesimi – il rimettente auspica un superamento di tali decisioni, argomentando che la diversità degli interessi coinvolti non comporta che quelli implicati nei giudizi civili siano di minore dignità ed importanza, potendo, come nei giudizi a quibus, concernere diritti fondamentali della persona;
che, aggiunge, la diversità fra i due modelli processuali, frutto della diversità degli interessi implicati, non giustificherebbe comunque la diversità fra i criteri di remunerazione degli avvocati interessati, in quanto la distinzione fra le situazioni soggettive tutelate riguarderebbe solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori che hanno uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno;
che, per il rimettente, un’ingiustificata disparità di trattamento sarebbe ravvisabile, nell’ambito dello stesso sistema del processo civile, fra la posizione dell’avvocato che abbia difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quella di chi abbia difeso una parte ordinaria, posto che i criteri di determinazione dei compensi professionali degli avvocati sono ancorati a fattori – quali il valore della controversia, la sua complessità, la quantità dell’opera prestata, la sua qualità nonché il risultato conseguito – per i quali è indifferente se a pagare il compenso sia direttamente il cliente ovvero un terzo, che in questo caso è lo Stato a ciò tenuto dall’esigenza di adempiere ad un dovere di solidarietà sociale;
che sarebbe perciò privo di ragionevole giustificazione lo “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la “devalorizzazione” delle identiche prestazioni in funzione del fatto che siano prestate o meno in favore di persona ammessa al detto beneficio;
che, prosegue il rimettente, ciò avrebbe altresì l’effetto, stante la minore remuneratività della prestazione professionale offerta in favore di chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di restringere il numero degli avvocati cui il non abbiente potrà rivolgersi rispetto a quello da cui potrà attingere il cliente che paghi direttamente il professionista;
che pertanto, chiarisce il rimettente, la minore appetibilità degli incarichi di patrocinio a spese dello Stato per il professionista che esercita in materia civile fa sì che il cliente non abbiente si trovi a poter scegliere il proprio avvocato fra un numero inferiore di professionisti rispetto a quelli da cui può attingere il cliente ordinario;
che tale discriminazione, fondata su ragioni economiche, è, come tale, “sospetta” di illegittimità costituzionale;
che essa, aggiunge il rimettente, non è, peraltro, frutto immediato della disparità economica esistente fra diversi cittadini, ma è la conseguenza del dettato legislativo che, anziché rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l’eguaglianza dei cittadini, ne erige uno dove non esisteva, né aveva ragione di esistere;
che il rimettente osserva ancora come la descritta disparità di trattamento può manifestarsi anche all’interno del singolo processo, ove una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, risultando violato, in tali casi il principio della “parità delle armi” nel processo, garantito dall’art. 111 della Costituzione;
che, ritiene il giudice a quo, le predette violazioni contrastino anche con il dettato dell’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, stante il contrasto della disposizione censurata con l’art. 6, primo comma, della CEDU, il quale assicura “l’effettività dell’accesso al tribunale” e la “parità delle armi”;
che l’unica finalità rinvenuta dal rimettente nel censurato art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 è quella di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, finalità che, più volte, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Convenzione ;
che, segnala il giudice a quo, la riduzione dei compensi determinata dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 opererebbe, in maniera del tutto eterogenea rispetto al predetto scopo, anche nel caso di condanna della controparte del non abbiente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di questo, in una ipotesi, cioè, in cui non sarebbero, comunque, interessate le finanze dello Stato;
che, per il rimettente, la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 53 della Costituzione;
che, osserva il rimettente, l’utilità economica della attività prestata dall’avvocato, liquidata in base a tariffe legalmente approvate, corrisponde alla somma determinata, in applicazione di quelle, dal giudice;
che da ciò conseguirebbe il credito, da parte dell’avvocato che abbia prestato la propria opera a difesa di un non abbiente in un giudizio civile, della integrale somma liquidata dal giudice;
che di essa, però, egli ne riceve solo una quota pari alla metà, la quale, aggiungendosi alle altre entrate del professionista, va a costituire il suo reddito imponibile, sul quale calcolare la relativa imposta;
che il restante 50% rimane nella disponibilità dell’Erario il quale, pertanto, consegue un beneficio economico equivalente a quello che realizzerebbe ove il professionista, ricevuta integralmente la somma a lui dovuta, ne dovesse riversare allo Stato, in aggiunta a quanto deve versare a titolo di imposta, la metà;
che siffatta attribuzione patrimoniale a favore dello Stato è, per il rimettente, assimilabile ad un’entrata tributaria;
che gli effetti favorevoli per l’Erario di tale meccanismo, secondo la ricostruzione operata dal rimettente, sarebbero ancora più evidenti nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia risultata vittoriosa in giudizio, poiché in tale ipotesi il giudice, nel condannare il soccombente a corrispondere alle casse dello Stato le spese di lite, non potrebbe che determinarne l’ammontare applicando, senza abbattimenti, le tariffe forensi, con la conseguenza che l’Erario incasserà dal soccombente l’intera somma liquidata dal giudice, ma ne riverserà al difensore della parte ammessa al beneficio solo la metà, trattenendo il resto, fatto che costituisce una vera e propria entrata tributaria;
che, non essendo quest’ultima calcolata in base ad aliquote previste per legge né rapportata al reddito imponibile del professionista e prescindendo il suo ammontare da ogni considerazione in ordine alla capacità contributiva di quest’ultimo o, eventualmente, della parte abbiente soccombente, la norma che la dispone è in contrasto con l’art. 53 della Costituzione;
che in ciascuno degli incidenti di costituzionalità si è costituito, con comparse di identico contenuto, il ricorrente nei giudizi a quibus, contestando in linea di principio la ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto tale norma deve intendersi abrogata per effetto della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006;
che, se tale tesi non fosse condivisa dalla Corte, la parte privata si associa alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per la infondatezza della questione;
che la difesa pubblica ricorda, infatti, come la giurisprudenza della Corte abbia già escluso la illegittimità costituzionale della disposizione censurata, osservando che: a) la garanzia del diritto di difesa non esclude che il legislatore lo moduli sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli; b) la differente disciplina del processo penale e di quello civile è giustificata dalla incomparabilità dei due modelli processuali; c) la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi; d) la circostanza che il difensore del non abbiente nel processo civile sia tenuto a prestare la propria opera per un compenso inferiore ai minimi tariffari, a prescindere dall’avvenuta abrogazione della inderogabilità di questi, non è fonte di illegittimità trovando fondamento in una norma di legge;
che l’affermata menomazione del diritto di difesa della parte non abbiente e la paventata frustrazione del diritto di accesso alla giustizia in condizione di parità delle armi, presuppongono che il difensore di questa, in ragione della minore prospettiva di guadagno, offra una prestazione professionale non adeguata;
che tale dato non può essere sostenuto in via di principio come effetto della norma censurata, rilevando, qualora si verificasse nel singolo caso, sul piano della deontologia forense;
che, in assenza di valide ragioni per discostarsene, l’Avvocatura chiede che siano confermate le precedenti decisioni della Corte;
che la difesa privata ha depositato, peraltro tardivamente, ampie memorie illustrative a conferma delle già rassegnate conclusioni.
Considerato che, con quattro ordinanze di identico contenuto, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi «sono ridotti della metà»;
che, secondo l’avviso del rimettente, detta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 53, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che, in particolare, il principio di eguaglianza sarebbe violato in ragione del deteriore criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti, e pertanto ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi civili (recte: in considerazione di quanto dispone l’intitolazione del Titolo IV del d.P.R. n. 115 del 2002 al cui interno è inserito il censurato art. 130: nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili), rispetto a quello, più vantaggioso, applicabile ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti nei giudizi penali;
che, secondo il rimettente, la disparità di trattamento, sarebbe, altresì, ravvisabile, anche fra difensori operanti nel comune ambito del processo civile (recte: nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili), nel diverso criterio di determinazione ope iudicis dei compensi in ragione della circostanza che la difesa sia resa in favore di soggetto abbiente ovvero di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
che, ancora, sarebbe violato il principio di eguaglianza, poiché, data la minore rimuneratività delle difese svolte nei giudizi civili (recte: nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili) in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese delle Stato, questi ultimi si troverebbero a poter scegliere il proprio patrono attingendo da un bacino di professionisti più ristretto di quello da cui possono attingere gli altri litiganti;
che, secondo il rimettente, sarebbero, in tal modo, violati anche: a) l’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, stante la derivante violazione del diritto di difesa; b) l’art. 111, primo comma, della Costituzione, data la violazione del principio di “parità delle armi” fra le parti nel processo; c) l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti umani, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto, in assenza di uno scopo legittimo, sarebbe limitata, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’effettività del “diritto di accesso al tribunale”;
che, prosegue il rimettente, la disposizione in esame – realizzando un prelievo tributario, nella misura della metà dei compensi liquidabili al professionista che abbia difeso il non abbiente nel giudizio civile (recte: nonché in quelli amministrativi, tributari e contabili), a carico o del professionista medesimo ovvero, in caso di condanna del contraddittore di chi sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato alla rifusione delle spese di lite, di quest’ultimo soggetto – violerebbe l’art. 53 della Costituzione prescindendo il predetto prelievo sia da aliquote predeterminate che dalla “capacità contributiva” dei soggetti incisi;
che i giudizi scaturiti dalla quattro ordinanze di rimessione, data la identità della questione da essi sollevata, debbono essere riuniti per essere definiti con un’unica decisione;
che, preliminarmente, deve essere valutata, sotto il profilo della perdurante rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, la incidenza sul presente giudizio della entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all’art. 9, prevede, rispettivamente al comma 1, la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (fra le quali vi è la professione forense), e, al comma 5, che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1»;
che, tuttavia, precisa il comma 3 del medesimo art. 9 (significativamente inserito in sede di conversione in legge dell’originario decreto), «le tariffe vigenti (…) continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2» (vale a dire dei provvedimenti con cui sono fissati i parametri di riferimento sulla base dei quali deve essere liquidato il compenso del professionista nel caso di determinazione da parte di un organo giurisdizionale);
che, per ciò che concerne le professioni vigilate dal Ministero della giustizia (fra le quali vi è quella forense), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 22 agosto 2012, per il fine sopra indicato, il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale, per quanto qui interessa, prevede, all’art. 41, che le disposizioni in esso contenute si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, fissata, dal successivo art. 42, nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che, pertanto, siffatto ius novum non interferisce sui giudizi a quibus, concernenti liquidazioni di compensi già da tempo operate sulla base della scrutinanda previgente normativa, sicché, quanto al profilo ora esaminato, la questione prospettata dal rimettente è tuttora rilevante;
che, sempre in limine litis, va esaminata la eccezione di inammissibilità della questione – dedotta dalla costituita parte privata nei giudizi a quibus e ribadita di fronte a questa Corte anche in sede di discussione orale – argomentata sulla base della asserita implicita abrogazione della disposizione censurata a seguito della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spese pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di (…) gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale»;
che siffatta eccezione va disattesa in quanto è del tutto plausibile l’interpretazione fornita dal Tribunale di Roma nelle ordinanze di rimessione, secondo cui l’indicazione della “tariffa professionale” quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato – tale è, infatti, chiaramente l’istituto che il legislatore intende richiamare allorché si riferisce al “gratuito patrocinio”- non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale;
che la questione è manifestamente infondata, sotto tutti i profili dedotti dal rimettente;
che, con riferimento alla asserita disparità di trattamento esistente fra avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, esercitino il loro ministero di fronte agli organi della giustizia penale, ed avvocati che, invece, operino, in difesa di soggetti aventi la medesima caratteristica, di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, contabile o tributaria, questa Corte osserva che la relativa questione già è stata esaminata e definita nel senso della manifesta infondatezza, sulla base del rilievo che, per un verso, «la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili (ordinanza. n. 350 del 2005) e che, per altro verso, la «diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate» (ordinanza n. 201 del 2006 che, a sua volta, riprende l’ordinanza n. 350 del 2005), laddove è di tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre;
che, riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati che, parimenti operando di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, tributaria o contabile, vedono i loro compensi ridotti della metà nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ritiene di doverla escludere;
che, neppure in questo caso, la diversa disciplina applicabile alle distinte fattispecie, una delle quali, quella relativa ai non abbienti, è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» (ordinanza n. 387 del 2004) – che hanno indotto questa Corte a ritenere (sentenza n. 114 del 1964), in vigenza di una precedente formulazione dell’art. 128, secondo comma, del codice di procedura penale, che prevedeva, in materia penale, l’obbligo della difesa gratuita dei non abbienti, non fondata la questione di costituzionalità allora posta con riferimento agli artt. 24 e 35 Cost. in quanto si trattava di una prestazione obbligatoria, radicata nell’art. 23 Cost., che aveva «la sua ragione nell’interesse pubblico» – non riscontrabili nell’altra, esula rispetto al margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali (da ultimo ordinanza n. 26 del 2012), nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia (ordinanza n. 446 del 2007);
che, sempre con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione – questa volta sospettata nella esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile, amministrativa, tributaria o contabile, data la minore rimuneratività di tale attività, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella cui può attingere il soggetto ordinario – questa Corte ritiene, per un verso, che la censura sollevata dal rimettente si risolva palesemente nella doglianza avverso un – peraltro solo postulato – inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione censurata ma, semmai, cagionato da scelte professionali del ceto forense;
che, per altro verso, più volte, questa Corte ha escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore – ora attraverso la individuazione di speciali elenchi da cui attingere (ordinanza n. 387 del 2004; ordinanza n. 374 del 2003) ora determinando al medesimo scopo, ambiti territoriali di riferimento (sentenza n. 394 del 2000) – ogniqualvolta ne sia comunque assicurata una ampia possibilità di scelta, circostanza quest’ultima senza dubbio riscontrabile nel caso di specie, tenuto conto che lo stesso rimettente indica, per il circondario di sua competenza, in alcune migliaia il numero di professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
che l’insussistenza dei predetti vizi di costituzionalità esclude anche la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, data la loro derivazione dalla affermata violazione del principio di uguaglianza;
che, infine, anche per quanto concerne l’asserito contrasto fra la richiamata disposizione legislativa e l’art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata;
che, per un verso, deve essere escluso – diversamente da quanto, invece, sostenuto dal rimettente – che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537);
che, per altro verso, nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi – giustificata, per come dianzi dimostrato, dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce – tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.
***
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad evocare i parametri costituzionali indicati senza argomentare in alcun modo in ordine alla loro asserita violazione.
FONTI
Sito uff. Corte cost., 2016
Deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537; Corte Cost., ordinanza n. 270 del 2012).
FONTI
Sito Il caso.it, 2016
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà.
Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia. L’asserita esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, sono meri inconvenienti di fatto irrilevanti nel giudizio di costituzionalità.
FONTI
Sito uff. Corte cost., 2016
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione: con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da “peculiari connotati pubblicistici” che rendono le fattispecie disomogenee e giustificano, quindi, il dimezzamento, frutto di esercizio di discrezionalità del legislatore (non irragionevole).
FONTI
Sito Il caso.it, 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Paolo GROSSI Presidente
– Giuseppe FRIGO Giudice
– Alessandro CRISCUOLO ”
– Giorgio LATTANZI ”
– Aldo CAROSI ”
– Marta CARTABIA ”
– Mario Rosario MORELLI ”
– Giancarlo CORAGGIO ”
– Giuliano AMATO ”
– Silvana SCIARRA ”
– Daria de PRETIS ”
– Nicolò ZANON ”
– Franco MODUGNO ”
– Augusto Antonio BARBERA ”
– Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento vertente tra C.M. e V.D. ed altro, con ordinanza del 18 giugno 2014, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che con ordinanza del 18 giugno 2014, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;
che in punto di rilevanza il giudice rimettente riferisce che all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, dove la creditrice istante era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la medesima ha domandato l’assegnazione del credito ed il suo avvocato ha chiesto la liquidazione degli onorari relativi al procedimento di esecuzione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 e quindi sarebbe tenuto a liquidare le spese dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95 del codice di procedura civile, a carico del debitore, assegnando i relativi importi dovuti dal terzo pignorato, in favore dell’erario, con prelazione sul ricavato dall’esecuzione a norma dell’art. 135 del D.P.R. n. 115 del 2002;
che l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà” e che in forza di tale disposizione, il giudice dovrebbe dimezzare l’importo medio previsto in funzione del valore della controversia ed attribuirlo al professionista solo nella misura così risultante;
che, in punto di non manifesta infondatezza, secondo il rimettente tale disposizione violerebbe l’art. 3 Cost. sotto i profili del principio di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto vi sarebbe una disparità di remunerazione tra quanto spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dovuto, secondo la tariffa professionale, ai difensori delle altre parti;
che sarebbero inoltre violati gli artt. 1, 35 e 36 Cost., che tutelano il diritto al lavoro e all’equo compenso per il lavoro prestato, senza discriminazioni;
che la disposizione impugnata violerebbe altresì gli artt. 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., in relazione alla parità processuale delle parti in giudizio, in quanto, nel caso di specie, essendo positivo il risultato del pignoramento, lo Stato potrebbe recuperare, con prelazione sulle somme dovute dal terzo pignorato al debitore, l’importo degli onorari previsti dalla tariffa di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247) e, quindi, la riduzione degli importi degli onorari difensivi prevista dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 produrrebbe il solo effetto concreto di avvantaggiare il debitore inadempiente, che godrebbe di un dimezzamento di quanto dovuto a titolo di onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mentre, quest’ultima, potrà essere condannata a pagare gli onorari per intero alla controparte;
che l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 incoraggerebbe quindi i soggetti economicamente più forti ad agire o resistere in giudizio in danno di soggetti economicamente più deboli;
che tale dimezzamento degli onorari non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato in forza del diritto di prelazione sul ricavato dell’esecuzione;
che, sebbene il rimettente affermi di essere consapevole che in passato la Corte costituzionale si era già pronunciata in più occasioni per la manifesta infondatezza della questione con le ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006, n. 350 del 2005, nondimeno ritiene che in quelle occasioni non sarebbe stata affrontata la questione inerente la differenza tra le posizioni processuali delle parti, in relazione alla possibile condanna alle spese ai danni della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che, in via subordinata, il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 1, 35 e 36 Cost., nella parte in cui non prevederebbe che, in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente, gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense, senza dimidiazione;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate per le ragioni già esposte dalla Corte costituzionale da ultimo nelle ordinanze n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, patrocinio erariale, quanto affermato in precedenza in relazione all’infondatezza delle questioni prospettate alla luce dell’art. 3 Cost. condurrebbe anche ad escludere la fondatezza delle censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., data la loro derivazione dalla affermata violazione del principio di uguaglianza;
che, si prosegue, la mancata trattazione nel giudizio costituzionale definito con la citata ordinanza n. 270 del 2012 della questione relativa al trattamento tra la parte ammessa al gratuito patrocinio e la controparte in punto di diversa modulazione dell’obbligo di pagamento alla parte vittoriosa delle spese processuali (per intero quanto alla parte ammessa al gratuito patrocinio e nella misura risultante a norma dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte abbiente) non sarebbe idonea ad aggiungere alcun rilevante profilo di novità;
che, infine, dovrebbe comunque essere escluso che ricorra una iniusta locupletatio dell’erario, stante che, in casi equiparabili a quello del giudizio a quo, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta penale, 8 novembre – 14 dicembre 2011, n. 46537) avrebbe puntualizzato che la somma che va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente.
Considerato che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;
che questioni analoghe a quella sollevata dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., sono state già affrontate da precedenti pronunce di questa Corte e risolte nel senso della manifesta infondatezza;
che con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha già affermato che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da “peculiari connotati pubblicistici” (ordinanza n. 387 del 2004), che rendono le fattispecie disomogenee;
che ciò è coerente con il margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali (da ultimo, ordinanza n. 26 del 2012), nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia (ordinanza n. 446 del 2007);
che, sempre con riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost. – questa volta ravvisata nell’esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella cui può attingere il soggetto ordinario – questa Corte ha affermato “che la censura sollevata dal rimettente si risolve palesemente nella doglianza avverso un – peraltro solo postulato – inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione censurata ma, semmai, cagionato da scelte professionali del ceto forense” (ordinanza n. 270 del 2012);
che “deve essere escluso … che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537)” (ordinanza n. 270 del 2012);
che è stato inoltre chiarito che “la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli (v., tra le altre, sentenza n. 394 del 2000; ordinanza n. 299 del 2002); … che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari” (ordinanza n. 350 del 2005; in senso conforme, ordinanza n. 201 del 2006);
che, pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, già rammentato nella citata ordinanza n. 270 del 2012 proprio con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia (ex multis, sentenze n. 243 del 2014, punto 2. del Considerato in diritto, e n. 157 del 2014, punto 4.1. del Considerato in diritto);
che la stessa Corte di cassazione ha affermato che il “criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario” (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 aprile 2013, n. 9808 del 2013);
che gli ulteriori profili in precedenza non considerati e che, secondo il rimettente, verrebbero in evidenza nel caso di specie, laddove la parte abbiente si avvantaggerebbe della condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio e agirebbe sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, si risolvono in realtà nella prospettazione di eventuali ricadute pratiche, vale a dire di mero fatto, in sede di applicazione della normativa censurata, sia in relazione all’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente, la quale potrebbe non farne richiesta o potrebbe vedere l’istanza respinta, sia in relazione all’esito del giudizio che conduca alla soccombenza a carico della parte abbiente, la quale, quindi, per beneficiare del presunto privilegio dovrebbe risultare soccombente;
che questa Corte ha già avuto in più occasioni modo di affermare l’irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata (ordinanza n. 112 del 2013; sentenze n. 247 del 2011; n. 329 e 298 del 2009; n. 86 del 2008 e ordinanza n. 123 del 2007) e che assumono il carattere di rilievi di opportunità (ordinanza n. 376 del 2007), per tale ragione attinenti a “materia propria dell’osservazione dei giudici di merito” (ordinanza n. 375 del 2006);
che, pertanto, tali questioni devono ritenersi manifestamente infondate;
che, con riguardo alle rimanenti doglianze prospettate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., il giudice rimettente si limita ad evocare i parametri costituzionali sopra indicati senza argomentare in alcun modo in ordine alla loro asserita violazione ed esse devono quindi essere dichiarate manifestamente inammissibili (ex plurimis, ordinanze n. 202 del 2009, n. 206, n. 204, n. 54 e n. 32 del 2008);
che, infine, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 proposta, in via subordinata, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui la norma impugnata non prevederebbe che – in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente – gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione, tale questione comporterebbe una pronuncia additiva;
che tuttavia tale tipo di pronuncia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presuppone l’impossibilità di superare la “norma negativa”, affetta da incostituzionalità, per via d’interpretazione, nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a “rime obbligate”; ex plurimis, sentenze n. 241, n. 81 e n. 30 del 2014), in particolare quando “”il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla ‘natura creativa’ e ‘non costituzionalmente obbligata’ della soluzione evocata (sentenze n. 241, n. 81 e n. 30 del 2014; ordinanza n. 190 del 2013)” (sentenza n. 241 del 2014), tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore (sentenza n. 277 del 2014)” (sentenza n. 23 del 2016);
che, diversamente, il petitum formulato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, talché anche la questione sollevata in via subordinata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.D.;
K.P.;
COMUNE DI BRESCIA;
nei confronti di:
M.B.E. N. IL (OMISSIS);
inoltre:
M.B.E. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 435/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito il difensore delle parti civili ricorrenti K.P. e S.D., Avv. Maione Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili N.A. e V. T., Avv. Ballerio Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi dell’imputato e del responsabile civile;
Udito il difensore delle parti civili R.F. e G. V., Avv. Pelucco Loretta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi dell’imputato e del responsabile civile;
Udito il difensore del responsabile civile, Avv. Scorza Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori dell’imputato, Avv.ti Gullotta Guglielmo e Scalvi Patrizia, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
l’incarico, conferito alle dottoresse P., S. e D. V., aveva per oggetto l’individuazione di eventuali sintomi di abuso sessuale e la valutazione della capacità di testimoniare dei bambini, in rapporto all’età. L’elaborato peritale era stato depositato nel dicembre successivo e, come detto, aveva concluso per la compatibilità dei sintomi con l’ipotesi di abuso sessuale e per la capacità testimoniale di tutti i minori, tranne F. S.. Nel (OMISSIS) G.V., mamma di un’altra bambina della scuola (OMISSIS), R.C., iscritta anche nell’anno precedente nella sezione verde, aveva riferito racconti della figlia aventi contenuto simile a quelli degli altri bambini e nei quali M.B. era indicato come autore di molestie sessuali commesse nei confronti della bambina nei bagni della scuola.
Nel (OMISSIS) F.A., S.G., R.C., N.R. e C.W. erano stati sentiti dal Giudice per le indagini preliminari nelle forme dell’incidente probatorio con audizione protetta; analogo atto non era stato disposto per F.S. per le difficoltà di eloquio del bambino. Infine, all’esito dell’ultima tranche di indagine, era stato individuato un quarto soggetto come possibile coautore di abusi commessi all’esterno della scuola: la coordinatrice scolastica M.D., iscritta nel registro delle persone indagate nel maggio 2003.
Di seguito venivano riportati nella sentenza i racconti riferibili a ciascun minore:
F.A., nata nel (OMISSIS), era iscritta fin dall’anno (OMISSIS) nella sezione rossa della scuola materna comunale “(OMISSIS)”. I genitori erano stati i primi e diretti testimoni dei malesseri manifestati da A.. Secondo quanto riferito al Tribunale dalla madre L.B., avvalendosi di un diario da lei redatto, a mano a mano che la figlia dipanava il suo narrato… A. era sempre stata una bambina allegra e vivace, che amava andare a scuola e che dormiva senza problemi nel proprio letto ma, dall’ (OMISSIS), era diventata nervosa, irritabile, si svegliava di notte in preda ad incubi e si arrabbiava anche con i suoi giochi preferiti, per esempio prendeva a calci un biberon gigante, che prima era solita vestire e coccolare. Non voleva più andare a scuola. Diceva ” A. è brutta” e, più volte, durante la notte, anche per più di venti minuti, teneva gli occhi sbarrati, lottava con mostri, si picchiava sulla bocca e diceva ” A. è brutta e cattiva, A. brutta schifosa, devo finire il lavoretto”, senza che i genitori riuscissero a svegliarla. I genitori avevano contattato il medico di base, che aveva consigliato loro di redigere una specie di diario, di non mandare a scuola la bambina e di rivolgersi ad una neuropsichiatra, la dott.ssa P.. La bambina diceva di aver paura della sua ombra, ombra che non usciva a scuola, perchè aveva vergogna delle maestre e dei compagni, ma usciva a casa e che, prima che lei iniziasse un lavoretto, la voleva graffiare e le diceva che non era bello. I genitori, seguendo le indicazioni della dott.ssa P., avevano esplicitamente chiesto alla bambina che cosa la facesse stare così male ed A. aveva risposto che non poteva parlare, perchè si vergognava e perchè le parole erano finite lì, indicandosi i genitali; li aveva invitati a chiamare le parole, cosa che avevano fatto, e la bambina aveva fatto il gesto di mettersele in bocca. Nei giorni a seguire la bambina aveva raccontato che la sua ombra l’aveva chiamata “brutta schifosa” intimandole di non dire nulla alla mamma e di andare a fare la pipì, anche se non le scappava, e aggiungeva che la sua ombra “voleva vedermi lì”, mentre faceva la pipì, indicandosi i genitali. Aveva, poi, sostituito quella che aveva chiamato la sua ombra con un grosso biberon che chiamava “ciuccio dicendo che si trattava di un “maschio che si chiama M., lo vedo ogni tanto, è magro, nanerottolo, con gli occhiali verdi, i baffi neri e pizzetto nero, ma non è G., perchè lui è bravo, è l’altro, a scuola sono tutti bravi tranne il ciuccio. La bambina aveva cambiato scuola e, dopo aver iniziato le sedute con la dott.ssa P., aveva problemi a scaricarsi e diceva che le sue feci erano schifose. Guardando un cartone animato in cui vi era un personaggio di nome B., la bambina aveva detto “Ecco come si chiama, B., mi è venuto in mente come si chiama quello con i baffi e i capelli neri, nanerottolo che è alla scuola vecchia”. Il (OMISSIS) A. aveva raccontato che B. nel bagno si era abbassato le mutande ed aveva un pisello enorme che sembrava un serpente, più grande di quello di papà; con le forbici aveva tagliato il serpente che aveva attaccato al pisello, in maniera che ne restasse fuori un pezzetto. La bambina aveva disegnato il pisello con il serpente su un foglio che aveva arrotolato facendo una specie di tubo che si era portata alla bocca, mimando quello che l’uomo aveva fatto e precisando che in bocca il serpente era molliccio e sembrava che si sciogliesse. A. raccontava che B. l’aveva fatta sdraiare, allargare le gambe ed aveva appoggiato il pisello lì – indicando i genitali – ed aveva spinto, spinto, spinto (“mi ha fatto male, mamma, per fortuna che ho stretto). Talvolta, durante i racconti, la bambina si masturbava e chiamava l’atto “stimolo-sudazione”. Parlando dello stimolo- sudazione, A. aveva spiegato, in termini figurati, che si trattava di una specie di razzo con la punta rossa che entrava nella sudazione; era un quadrato con dentro “la croce di Bombard”, lo stimolo entrava nella sudazione – che era A. – ed usciva più piccolo con la croce di Bombard. La bambina aveva disegnato B. con un razzo in mano e lei con le gambe piegate all’indietro. Giocando con tre personaggi aveva raccontato che B. l’aveva portata a casa sua, descritta come una casa piccola, con un bagno ed una sala con televisione; per arrivarci si scendeva una scala, si camminava un pezzettino e poi si risaliva, giungendo ad una porta dove c’era la croce di Bombard: una croce con attorno un filo di ferro e dei fiori tutti colorati dove le facevano fare il balletto. I tre personaggi erano una dottoressa, un maschio ed una femmina. La dottoressa doveva curare il pupazzetto maschio perchè era malato ed aveva lo stimolo-sudazione, lo curava facendogli la pipì addosso. A. aveva riprodotto l’ansimazione ed aveva detto che “lui” le aveva fatto la pipì addosso, perchè così guariva, indicando la zona dell’ombelico…Aveva poi narrato che la dottoressa passava lo stimolo a B. che “lui mi metteva nel culetto, ma io stringevo, che c’era una cinepresa con una lucina che assomigliava a quella che usavano quando festeggiavano il suo compleanno, mentre la macchina fotografica era sul tavolo. Oltre a B. ed alla dottoressa, a casa di B. c’erano anche altre persone ma B. aveva detto di non dirlo a nessuno, aveva detto che le avrebbe sparato se avesse rivelato quello che faceva….Aveva raccontato che la dottoressa si chiamava L. e che la teneva ferma mentre B. le faceva le perette dure, di colore grigio, che scottavano, bruciavano, vibravano e le provocavano un forte dolore, la bambina aveva mostrato di capire cosa significasse il termine vibrazione. A. aveva costruito una casa dicendo che per entrarvi era necessario percorrere una discesa ed entrare in un garage che non aveva la saracinesca, si saliva poi a piedi e, dopo aver camminato per un pezzettino passando da un giardino ove era un grande albero, si salivano le scale ed alle finestre vi erano delle sbarre per non cadere. Quando finivano i lavoretti a scuola, lei e I. (che era una compagna di classe), le maestre dicevano che dovevano andare in bagno, ove le raggiungevano B. e la dottoressa che le prendevano e le portavano a casa loro. Poi A. doveva vedere I. quando le facevano male ed I. doveva vedere A.. A. aveva difficoltà a scaricarsi perchè diceva che le facevano schifo le sue feci in quanto le ricordavano quando B. le faceva le brutte cose; aveva raccontato di aver vomitato dopo aver visto un compagno star male in classe ed in quel momento di essersi ricordata di quando B. le aveva messo il pisello in bocca. Non aveva voluto partecipare alla festa di Carnevale della nuova scuola perchè aveva saputo che a scuola c’erano i pagliacci e lei aveva paura. Quella notte aveva avuto un sonno agitato ed al risveglio aveva raccontato che nella casa di B., dove c’era anche la dottoressa, le altre persone erano vestite da pagliaccio e le facevano male: le donne le facevano le perette come quelle che usava B. e gli uomini l’avevano fatta vomitare come aveva fatto lui con il pisello, facendole anche le fotografie, scrivendo sopra qualcosa e dicendole che le avrebbero tagliato la testa se fosse stata ancora male. Aveva anche raccontato un episodio in cui parlava del trapano e della poltrona del dentista; la poltrona del dentista era blu, si muoveva, ci si poteva sdraiare ed anche appoggiare le gambe e che era a casa di B.; gli uomini vestiti da pagliacci andavano in bagno e si prendevano in mano il pisello, facendosi la pipì sulle mani ed ordinandole di stare ferma a guardarli. Indicando l’ano, aveva detto che B. le aveva fatto la puntura lì e che poi si era, addormentata per finta, ma le faceva molto male. Aveva raccontato che nel giardino della casa B. aveva acceso il fuoco, che c’erano altri uomini vestiti da donna con i capelli colorati e le donne vestite da pagliaccio che le facevano male in tutto il corpo, alle braccia e alle gambe; che tutte quelle persone facevano rumori forti.
Aveva, infine, narrato di essere stata legata dai cattivi alle gambe ed alle braccia con una corda mentre le persone ballavano intorno a lei muovendo la lingua e facendo dei versi, colpendola al petto con cose verdi simili a fruste.
La perizia ginecologica aveva dato esito negativo ma alla bambina era stata diagnosticata una vulvite.
Nel corso dell’incidente probatorio, svoltosi il 21 febbraio 2003, A. non era riuscita ad esprimersi compiutamente, limitandosi per lo più a confermare con cenni della testa affermativi o con dei “sì” le domande rivoltele dal Giudice, coadiuvato dalla psicologa.
Alla domanda se le cose brutte le avevano fatte i grandi o i piccoli, aveva fatto cenno di sì e poi aveva detto “andi”, spiegando con un cenno affermativo della testa che intendeva dire i grandi e che si trattava di grandi maschi e grandi femmine. Chiestole se le cose brutte fossero successe all’asilo, aveva fatto cenno di no e se fossero successe fuori aveva fatto cenno di sì; aveva risposto no alla domanda se le fossero piaciute, aggiungendo che vi era una persona con i capelli neri. Chiestole chi fosse stato ed elencati molti nomi aveva fatto sempre cenno negativo con la testa, fino al nome B.; a questo punto, aveva fatto cenno di sì ed aveva pronunciato il nome Battista, che non era un maestro. Aveva indicato una lunghezza di venti centimetri della peretta ed aveva detto che era dura; aveva detto che un signore, che poi aveva chiamato B., l’aveva in mano e le aveva fatto male al sederino. Aveva risposto che quelle cose B. le faceva in bagno, quando era solo. Aveva risposto sì alle seguenti domande: se le persone cattive avessero la faccia mascherata e le parlassero; se l’avessero portata in qualche casa; se vi fossero letti; se vi fossero persone che erano prima vestite e si fossero poi svestite; se fosse sdraiata quando le avevano messo la peretta nel sederino; se qualcuno le avesse ordinato di sdraiarsi.
F.S., nato nel (OMISSIS), nel (OMISSIS) frequentava il primo anno della scuola materna, nella sezione (OMISSIS). La madre, R.M., aveva riferito in dibattimento che il bambino soffriva di un blocco nell’area del linguaggio ed aveva un significativo problema di stipsi, non ancora risolto dall’età di tre mesi. Una volta S. era tornato da scuola senza le mutandine, in quanto non era stato trovato il cambio, ed in quell’occasione il bambino le aveva riferito che a scuola lo cambiava il signore con i baffi, mimando la presenza dei baffi sotto il naso. Durante le vacanze di Natale la cognata, L.B., le aveva accennato a “fatti di sesso orale e di preservativi colorati” senza fare alcun nome, ed a partire da tale periodo aveva notato nel figlio alcune anomalie. S. aveva iniziato ad imitare una voce roca, da uomo adulto, voleva portare a scuola un bambolotto, reagiva piangendo quando lei gli puliva il sederino con le mani, cosa mai successa. Il bambino le aveva fatto capire che quando faceva i bisogni a scuola veniva cambiato da un uomo con i baffi, che gli veniva tolta la maglietta e che gli facevano bere qualcosa; aveva mostrato tristezza durante il racconto mimando la macchina fotografica. Successivamente il bambino aveva composto un cerchio con il pollice e con l’indice e poi si era portato le mani all’altezza della bocca e, quindi, in mezzo alle gambine, aveva preso il dito della madre e l’aveva spinto avanti ed indietro. Da allora il bambino aveva manifestato paure mai avute per le campane, i camini, il fumo, ed aveva preso il vizio di baciarla sulla bocca, le infilava spesso la mano al di sotto della maglietta ma con modi che la donna aveva definito “pesanti”. Il fratello più grande aveva sorpreso S. in camera mentre giocava con il cugino con le mutande abbassate ed il membro fuori e, quando era stato sgridato, aveva detto che il signore con i baffi faceva così. A giugno il bambino era diventato aggressivo, prendeva a pugni tutte le figurine disegnate sul copriletto e si definiva “brutto cattivo”. Nel luglio le si era presentato con il trasformatore del telefono dentro le mutande e le aveva detto di guardare e che quella cosa si metteva dentro, indicando il sedere. Durante l’estate, le aveva avvicinato un mestolo di legno ai genitali e le aveva detto che si trattava di un gioco bellissimo. Successivamente il bambino aveva cominciato a parlare e nel (OMISSIS) aveva esclamato “mamma, sai che il pisello è arrivato fino giù in gola?” e, in un’altra occasione, mentre gli puliva il sederino, le aveva detto “mettimi dentro bene il ditino”. Le aveva chiesto se i lupi fossero nudi, aggiungendo che sarebbe stato bello picchiare con un bastone i lupi.
N.R., nata nel (OMISSIS), frequentava la scuola materna (OMISSIS) nell’anno (OMISSIS) come mezzana nella sezione arancio.
Erano state le insegnanti le prime destinatane delle confidenze della bambina. La maestra aveva riferito che, alla fine dell’anno scolastico (OMISSIS), R. aveva assunto improvvisamente comportamenti aggressivi; al rientro dalle vacanze si rifiutava di entrare a scuola, faceva capricci tutte le mattine ed in classe accusava mal di pancia e vomito. Un giorno aveva disegnato una mano pelosa ed aveva affermato di avere molta paura di essa. L’ (OMISSIS) si parlava in classe di cosa accadesse in famiglia la mattina e R., disegnando sè stessa sotto la doccia, aveva interrotto il disegno mostrando forte agitazione. Nel pomeriggio dello stesso giorno si era avvicinata alla maestra dicendole che B. l’aveva disturbata; la maestra l’aveva invitata a fare un disegno di quanto accaduto, ma la bambina aveva rifiutato. La maestra aveva verbalizzato per iscritto quel che la bambina le aveva detto ” B. quello che ci porta in bagno mi ha disturbato, mi ha toccato con il dito davanti il culetto mentre facevo la pipi”. La bambina aveva poi eseguito numerosi disegni ripetendo più volte il medesimo racconto “io ero in bagno e quando mi sono girata mi ha toccato il culo, questo lo dico al mio papà”. Qualche giorno dopo la bambina aveva visto il M. che, pur essendo assegnato dal (OMISSIS) ad altro servizio, aveva portato della posta a scuola e si era precipitata spaventatissima dalle maestre dicendo che aveva paura. Le maestre avevano chiamato il direttore dott. B., che aveva constatato di persona lo stato di agitazione della bambina ed appreso dalla stessa quanto fattole da B.. La maestra riferiva di aver appreso, nel (OMISSIS), da cinque bambini ( R.G., C.W., F.E., M.A. e N.R.) che erano stati portati in cantina; i bambini riferivano di essere andati in cantina con l’ausiliaria F. e di aver visto una stanza che, dalla descrizione fornitale, le risultava sconosciuta. Aveva detto ai bambini di farle vedere questo locale ed era scesa in cantina munendosi di registratore. I bambini l’avevano condotta in una stanza, dicendole che vi erano stati anche con B.. Si trattava di un locale diverso da quello in cui erano custoditi i giochi ed era quello di pertinenza dell’appartamento del custode.
Alcuni bambini, fra cui C.W., davano conto perfettamente di esservi già stati. Il padre di R. riferiva di aver notato, rispetto al passato, che la bambina faceva i capricci quando entrava all’asilo, frequentemente si faceva la pipì addosso e da dicembre aveva accusato un forte dimagrimento. Nei primi mesi del 2002, per due o tre volte, trovandosi nel lettone con i genitori per vedere la televisione, R. aveva toccato nelle parti intime lui, il fratello e la madre; sgridata, era scappata in camera sua a piangere. Sempre nel medesimo periodo, R. afferrava i suoi giochi dicendo “sei cattivo, ti strangolo e staccava la testa della Barbie. La madre di R. riferiva che la bambina, ad esplicita domanda, aveva detto che B. l’aveva portata in cantina dicendole che lì c’erano dei giochi; aveva spento la luce ed aveva fatto il verso del fantasma aggiungendo “adesso starai lì per dei mesi”. Si era spaventata e si era fatta la pipì addosso; le aveva poi aperto la bidella. Dopo qualche giorno la bambina aveva riferito che il bidello in bagno le aveva toccato il culetto con il dito (mostrava il dito medio della mano) ed aveva affermato che era stata toccata anche sulla passerotta con un crocefisso che l’uomo portava al collo e che B., toccandola in quel modo, le aveva detto “questo lo hai voluto tu”. Anche la madre aveva notato comportamenti anomali della bambina nel periodo precedente le rivelazioni: si rifiutava di andare all’asilo, si faceva spesso la pipì addosso, aveva numerosi incubi notturni, sognava una mano pelosa, non voleva più mangiare e dimagriva a vista d’occhio, aveva atteggiamenti aggressivi nei confronti delle bambole, spesso diceva “sono stupida, schifosa, brutta”, rifiutava di andare in bagno e piangeva in modo disperato, non voleva dormire da sola, toccava il padre, cercando di morderlo nelle parti intime e cercava di tirare giù le mutande al fratello sedicenne.
Nel corso dell’incidente probatorio R. aveva narrato che, in bagno, B., bidello dell’asilo, mentre aveva ancora i pantaloni ed il collant abbassati, le aveva dato un pugno sul culetto e lei aveva avuto paura, anche perchè B. le aveva anche detto che era stupida e l’aveva diffidata dal parlarne con le maestre, cosa che invece aveva subito fatto. B. l’aveva anche chiusa in cantina, all’asilo, e le aveva fatto il rumore dei fantasmi con la luce spenta. C’erano solo lei e B., che era cattivo ed era vestito tutto di bianco come un fantasma. Aveva chiesto al giudice di comandare ai poliziotti di mettere in prigione le persone cattive e di lasciare in prigione B. perchè l’aveva picchiata.
C.W., nato nel (OMISSIS), nell’anno scolastico (OMISSIS) frequentava la sezione arancio ed era il più grande della sua classe. Il padre del bambino, a seguito della convocazione in Questura, dove era stato messo al corrente di ipotesi di abuso nella scuola, aveva ripensato ad alcuni strani comportamenti del figlio manifestatisi prima del (OMISSIS), ossia prima che il bambino si fratturasse il braccio: non voleva più stare al buio e voleva che la luce restasse accesa quando andava a letto, faceva i propri bisogni nel letto, pur avendo smesso da tempo di farlo, gli bruciava il sederino, era più nervoso ed aveva scatti d’ira, lo toccava e si toccava in mezzo alle gambe; spesso W. gli diceva “Dammi la lingua, facciamo l’amore” e poi gli toccava il pisello. Di notte spesso si svegliava, tutto sudato, e si lamentava esclamando “..no, lasciami stare”. A sua domanda, il figlio gli aveva raccontato che l’avevano portato in cantina, che un giorno B. gli aveva bloccato le braccia ed aveva tentato di baciarlo sulla bocca e lui gli aveva dato un calcio; verso la metà di (OMISSIS) il bambino gli aveva raccontato la storia di un lupo di nome G. che andava in cantina dove c’era una lupa buona cui volevano far del male e lui scappava. F. lo teneva o lo portava via, il padre non ricordava esattamente; lui doveva fare le coccole al lupo maschio ed erano coccole che di solito una donna faceva ad un uomo. Nella primavera del (OMISSIS), riferiva la cugina di W., il bambino facendo un disegno le aveva detto che voleva rappresentare un bambino che stava in una stanza buia, che aveva le mani legate e che chiamava il suo papà senza ricevere risposta. Quel giorno aveva fatto un altro disegno, nonostante fosse molto agitato, in cui aveva raffigurato se stesso sdraiato con una lupa e un lupo di nome G. ciccione e con un cappello colorato; asseriva di fare le coccole al lupo (quelle che i maschi facevano alle femmine).
Nel corso dell’incidente probatorio W. aveva dichiarato che all’asilo erano successe cose strane che non gli erano piaciute, cose fatte dai grandi e non dai bambini. Alla domanda di chi si ricordava dei grandi, aveva risposto ” B.”; aveva affermato che B. lo aveva messo in cantina e “mi voleva dare il bacio con la lingua, invece io gli ho dato un calcio; in cantina era andato con B. e dei grandi c’era solo lui. B. aveva chiuso la porta, aveva spento la luce, ma “io ho acceso col ferro in cantina, l’ho preso e ho buttato giù la porta con il ferro; era un ferro grigio e la cantina era tutta vuota, solo che c’erano tutti ferri, buttati, e quello da lui usato era un ferro triangolare. B. lo aveva anche sorpreso in bagno mentre si stava lavando e lo aveva toccato alla spalla, spaventandolo e facendogli male perchè lo schiacciava. Si era rifiutato di rispondere ad altre domande, dicendo solo che non voleva riferire cosa accadeva nella stanza in cantina e che era una cosa che conosceva solo lui; dettogli che altri bambini avevano raccontato quanto accaduto, rispondeva che non ricordava più nulla e che lui ( B.) era diventato buono e gli diceva “Ormai sono diventato buono. Si trattava di un segreto e B. gli aveva detto di non raccontarlo a nessuno: B. gli faceva male alla spalla perchè voleva spingerlo a terra, ma lui resisteva e non si sedeva; raccontava poi di aver visto grandi senza vestiti, in televisione, in mezzo alla neve, nudi (“che schifo, anche i maschi”).
S.G., nata nel (OMISSIS), nell’anno (OMISSIS) frequentava la scuola materna (OMISSIS) come mezzana nella sezione gialla. La madre, K.P., riferiva di aver saputo solo il 3 giugno 2002 che una bambina era stata molestata da un bidello e di avere la sera stessa chiesto alla figlia se conoscesse B. e se con lui avesse fatto dei giochi. La bambina aveva inizialmente detto che B. a volte l’aveva accompagnata al bagno senza farle alcun male ed aveva anche fatto con lei dei giochi normali e poi il “gioco della neve”; si trattava di un gioco in cui lei doveva spalmare una cremina su tutto il corpo di B. ed una schiuma sul suo pisello e sul suo sedere (la schiuma usciva da una bomboletta, schiacciando con un dito); quando veniva fatto il gioco della neve c’erano anche altri bambini. Un giorno, mentre si trovava in classe da sola, B., che era in compagnia di un amico di nome G., le aveva infilato un dito nella pisellina, facendole molto male. Lei aveva gridato per il dolore ma nessuno l’aveva sentita. La madre ricordava che dall’ottobre 2001 G. aveva avuto spesso incubi notturni, da lei inizialmente imputati al fatto che aveva ripreso il lavoro a tempo pieno, che era tornata a volte da scuola con le mutandine sporche e le parti intime arrossate, che le maestre le avevano segnalato i suoi frequenti stati di agitazione, mentre una volta, al contrario, la bambina si era addormentata e non erano riuscite a svegliarla, tanto che avevano chiesto ai genitori se G. assumesse farmaci; quando la portava al parco, la figlia chiedeva subito di tornare a casa perchè i bambini le dicevano che era schifosa, brutta, un mostro. Il (OMISSIS), mentre era in macchina con la madre e stavano parlando delle fotografie scattate durante il matrimonio della zia G. aveva detto che alcune persone cattive le avevano fotografato la pisellina e aggiungeva che doveva spogliarsi, tirare indietro le gambe portando le ginocchia verso le spalle ed allargare la pisellina: in quel momento venivano scattate le fotografie; ciò accadeva in due diverse case alla presenza di molte persone e lei si vergognava molto: la prima casa era sopra l’asilo, cui si accedeva scavalcando una ringhiera aiutata dalla maestra D., e la seconda casa era collocata all’esterno, dove era accompagnata da una persona anziana, tale G., e poi riportata all’asilo dalla maestra C., casa che G. indicava in uno stabile in via (OMISSIS), vicino ad una farmacia. Nella casa vi era G. ed altri cattivi fra cui B., una tale M. ed una direttrice che comandava i cattivi. La bambina continuava con la descrizione del “gioco della forbicetta”, svoltosi in una casa diversa dalle prime due, ove vi erano persone cattive che volevano levarle dalla pisellina la forbicetta che le faceva molto male, in quanto era in fondo in fondo e per tirare fuori la forbicetta dovevano metterle anche una spada.
Questa cosa avveniva in una “trappola” fuori dall’asilo che chiamava “isola degli squali”. Lo stesso giorno, G. aveva detto che nella cantina dell’asilo, dove andava a prendere i giochi belli e brutti e dove la portavano B. ed altre persone, vi erano i grandi e i buoni che facevano la guerra contro i grandi cattivi. Una maestra di nome C. l’aveva minacciata di picchiarla e le aveva messo un’unghia dentro l’occhio facendole male; anche gli altri cattivi l’avevano minacciata che se avesse raccontato qualcosa ai genitori avrebbero ammazzato o lei o mamma e papà. Sempre nel mese di giugno, durante attività ludiche in casa, G. spontaneamente aveva parlato di una trappola sul retro dell’asilo, dove c’era la cucina, cui si giungeva o attraverso il tombino posto sul retro dell’asilo – che G. le aveva mostrato un pomeriggio, mentre si stavano recando dal medico – o attraverso un passaggio posto vicino alla rete. La trappola era in fondo a delle scale, era buia e lì c’erano dei cattivi con degli occhiali: lei andava lì per salvare una bambina di nome A., di una sezione diversa dalla sua. Con riferimento all’isola degli squali, G. aveva detto alla madre di esservi stata portata in inverno con una macchina: lì si facevano giochi belli (lei doveva sputare sopra lo squalo e lo squalo diventava buono) e giochi brutti (i cattivi le davano baci sulla bocca, le sputavano veleno in bocca che lei doveva ingurgitare nonostante le facesse schifo). I cattivi erano vestiti da faraone, dracula e da pagliacci. G. aveva chiesto alla madre se le unghie si potessero perdere e se i chiodi sopra le unghie provocassero dolore. Nel mese di (OMISSIS), presso la sede di (OMISSIS), G., in presenza del pubblico ministero, aveva riconosciuto in fotografia B. dicendo che l’uomo non era più all’asilo ed era diventato buono, e una persona che indicava come H. o J., che corrispondeva alla M.. La bambina aveva detto che era un uomo e che era buono. Nell’occasione, G. si era rifiutata di ripetere al pubblico ministero i racconti fatti alla madre, perchè, sosteneva, aveva paura che i cattivi lo venissero a sapere. Il (OMISSIS) la K. si era recata in Questura ed aveva riferito le ulteriori rivelazioni della bambina e, in particolare, che, nel pomeriggio del (OMISSIS), mentre stavano andando al parco (OMISSIS), passando davanti allo stabile di via (OMISSIS), abitazione della P. (come lei aveva letto nella richiesta di incidente probatorio notificatale pochi giorni prima), aveva chiesto alla figlia se avesse mai visto quella casa, senza aggiungere altro. G. le aveva risposto, subito, che quella sembrava proprio “la caverna della G.” e cioè della sua bidella dell’asilo che spesso le faceva anche le coccole. Quindi aveva proseguito raccontando che era stata portata in quel posto dai cattivi che le avevano detto che sarebbe andata dalla dottoressa. Alla casa, che G. chiamava “caverna”, si accedeva passando sotto un portico (ed in effetti, aggiungeva la teste, lo stabile aveva un porticato) e, prendendo l’ascensore, si saliva in casa ove erano B., G. e M.. La madre aveva riconosciuto che, pur essendo passata altre volte vicino a quella casa, la bambina mai aveva manifestato segni di disagio. G. aveva raccontato che i cattivi la facevano stendere su una sdraio e G., aiutata da M. (che solo successivamente in autunno, la figlia chiamerà F., come un’altra bidella dell’asilo, M.F.) le metteva una cremina sulla pisellina e sul culetto, poi le infilava nella pisellina una forbicetta che le faceva molto male e per toglierla le infilavano la spada. Anche lei doveva spalmare la cremina sulla pisellina delle femmine e sul pisello dei maschi. Indicava che erano presenti anche otto persone ( G., all’epoca sapeva già contare). Riferiva anche di un cattivo sdraiato su un tappeto del bagno che si faceva spalmare la cremina sul pisello, da cui, mentre lei spalmava la cremina, usciva la pipì ed i cattivi gliela facevano leccare e mandare giù. Lei provava schifo e le veniva da vomitare, per questo la sgridavano. In precedenza, forse a giugno, la bambina le aveva raccontato che G., in un posto fuori dall’asilo, le aveva fatto una puntura nella pisellina. Quando accadevano queste cose le maestre non c’erano, secondo G., in quanto erano a bere il caffè; la bambina raccontava di avere detto alla maestra che lei andava a combattere i cattivi, ma la maestra non aveva detto nulla. La teste aveva riferito che la bambina, nei diversi racconti ed anche disegnando, aveva raccontato di tre diverse caverne ove avvenivano gli stessi fatti della cremina e della forbicetta: una della G., una di M. (poi diventata la caverna di F.), dove le mettevano un martello nella pisellina, ed una di B., nella quale quest’ultimo si vestiva da uomo ragno. I disegni rappresentavano caverne, grate, persone cattive, animali che le facevano male. Spesso i racconti erano fatti quando lei sgridava la bambina e, in seguito a tali rimproveri, G. accusava la mamma di fare come i cattivi e come la dottoressa che comandava. Solo il (OMISSIS) G. aveva introdotto la figura della “dottoressa”, in quanto prima aveva parlato solo di “direttrice che comandava”. Circa due mesi prima dell’udienza G. aveva indicato la dottoressa con il nome di L. o L…..La nonna di G. aveva riferito che nel (OMISSIS), andando a prendere G. a scuola, aveva notato che era un pò agitata ed in un’occasione si era messa a piangere;
chiestole cosa avesse, G. aveva risposto che a scuola c’erano i cattivi. Un’altra volta si era accorta che la nipote era un pò intorpidita, come addormentata. La maestra le aveva comunicato che si era appena svegliata. Da quel periodo in poi, la nipote non aveva voluto più che lei le facesse il bagnetto: si irrigidiva ed urlava di non toccarla nelle parti intime, stringendo le gambe e piangendo disperatamente. Le insegnanti C. e V., soprattutto quest’ultima, avevano confermato che G., nei mesi precedenti le rivelazioni degli abusi, aveva effettivamente tenuto condotte singolari e anomale rispetto al passato.
Nel corso dell’incidente probatorio, chiestole cosa era successo di brutto all’asilo l’anno precedente, G. aveva dichiarato che all’asilo le avevano fatto male alla pisellina e al culetto; erano stati B., la G., la L., e poi G. e S., che definiva come persone cattive. Alcuni di loro stavano alla loro casa, mentre uno la veniva a chiamare quando era in salone (nell’asilo vecchio) con le maestre a giocare. B., la G. e la L. erano bidelli, non maestri. A casa della G., c’erano persone vestite stranamente come a carnevale. La L., la F., la G. e B. le avevano fatto male al culetto ed alla pisellina. G. e L. le avevano messo una forbicetta nella pisellina: L., F. e B. le avevano messo la cremina;
Tutto questo era accaduto una volta o due. La casa era della G., perchè c’era scritto G. sul cartello; ricordava le scale e la porta “di dottoressa”. Fuori della casa della G. c’era un giardino, ove le avevano fatto le altre cose, cioè la forbicetta nella pisellina e la puntura; la forbicetta era fredda ed era lunga circa cinque centimetri (la bambina faceva il segno). Quando le mettevano la forbicetta, le davano dei pizzichini sulla pisellina e lei non sapeva dove fossero gli altri bambini, ma anche a loro erano fatte le stesse cose. R. e S. piangevano. Tornava nell’asilo passando dal cancello ed era B. a riportarla.
Quando usciva non aveva il grembiulino ed era B. a guidare la macchina che era nera, grandissima e vi erano seduti, dietro con lei, gli altri cattivi. Alla maestra non aveva detto nulla, anche perchè i cattivi le avevano raccomandato di non dire nulla a nessuno, altrimenti sarebbero andati a prenderla nella sua casa. Nell’asilo non era successo niente, ma le persone cattive, erano cattive anche all’asilo.
Nell’anno scolastico (OMISSIS) R.C., nata nel (OMISSIS), frequentava come piccola la sezione verde della scuola. La madre aveva dichiarato in dibattimento che, quando nel giugno 2002 aveva appreso degli abusi e dei sospetti ricadenti sul M., aveva esplicitamente chiesto alla figlia se B. l’avesse importunata, ricevendo risposta negativa. Già a partire dall’estate (OMISSIS) aveva, però, notato la figlia toccarsi insistentemente i genitali e cercare di toccarli anche a lei sopra i vestiti, ma di aver attribuito tali comportamenti alla scoperta della sessualità.
Nel (OMISSIS) la teste aveva notato nella figlia, i comportamenti più spiccatamente sessualizzati. Una sera, per esempio, aveva visto C. toccare la sorella M. nelle parti intime dopo averle tolto i pantaloni e dicendo “la pisella di M.”. Visto ciò, l’aveva apostrofata “Ma C., cosa stai facendo? Fai come faceva B., quel maniaco?”. Alla domanda la bambina si era bloccata, facendosi la pipì addosso (cosa che accadeva molto raramente) e mentre la accompagnava in camera per cambiarsi, le aveva detto “Mamma ti devo dire una cosa, è un segreto tra me e te, non fare venire il papà e la M.”, proseguendo con ” B. mi baciava sulla pisella”, e chiedendo a questo punto alla madre di fare altrettanto. La bambina aveva aggiunto “Poi mi toccava con il dito, mostrandole come ciò avveniva e toccandosi anche il sedere con il dito, precisando che la cosa le aveva fatto schifo, perchè la bocca di B. puzzava di altre piselle. La bambina, nel raccontare, mostrava molta vergogna e si rannicchiava, ridendo nervosamente. Il giorno successivo, mentre stava rifacendo il letto matrimoniale, aveva proseguito la teste, aveva esclamato in presenza della bambina “Che odore di piedi, che puzzone il papà”.
Nel corso dell’incidente probatorio, R.C., a voce bassissima e cantilenante, aveva dichiarato che all’asilo c’era B. che le baciava la farfallina, gliela baciava e gliela puliva e così faceva, perchè lo aveva sentito, anche con la farfallina della sua amica S.; B. la baciava sui pantaloni e con le mani non faceva nulla. La cosa era successa nel bagno tante volte e sempre nello stesso modo; mentre la baciava, B. le diceva che era una mongola, perchè lei non voleva e lui le dava comandi brutti (“erano cose schifose”). B. le tirava giù i pantaloni e lei sentiva la bocca addosso, sui vestiti;
piangeva e si arrabbiava ed aveva detto di smetterla chiamandolo “brutto”. Aveva precisato che il bacio di B. era una leccatina. Aveva raccontato la cosa a due maestre. Le maestre avevano confermato che nel (OMISSIS) la bambina aveva detto loro che B. l’anno prima “ci faceva i dispetti” e “ci stufava” perchè “quando eravamo in bagno…ci toccava la farfallina e…la leccava”.
Ulteriori elementi di illogicità erano stati segnalati dai giudici di legittimità con riguardo agli abusi commessi fuori dall’istituto, attraverso la organizzazione di feste orgiastiche alle quali, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano partecipato diverse persone, posto che non era stata trovata traccia dei vestiti e delle maschere usati dai partecipanti ai festini, degli strumenti utilizzati per usare violenza ai minori, delle macchine fotografiche e delle videocamere che avevano, secondo l’accusa, immortalato le turpi scene. Secondo la citata sentenza di annullamento, i giudici del merito neppure avevano dato conto, con la necessaria coerenza logica, del permanere del giudizio di attendibilità delle piccole A. e G., pur dopo che i proprietari delle abitazioni, indicate come i luoghi in cui erano stati perpetrati gli abusi, cioè lo studio del dentista e l’abitazione dell’altra ausiliaria, erano stati prosciolti da ogni accusa. Ancora, i giudici di legittimità avevano rilevato elementi di illogicità laddove la Corte territoriale aveva ritenuto possibile che gli allontanamenti dei minori dall’istituto fossero avvenuti durante le ore di scuola senza che nessuno si fosse accorto della loro scomparsa, peraltro approfittando delle pause di riposo delle insegnanti, e senza che i genitori avessero percepito malesseri di alcun tipo nei bambini, al termine dell’orario scolastico. Di qui, la sentenza di annullamento e l’invito ai giudici del gravame di riesaminare l’intero contesto probatorio e di valutare, altresì, l’opportunità di procedere ad esame diretto della piccola A., ovvero di disporre, nei confronti della stessa, un’indagine psicodiagnostica diretta a valutarne la capacità a testimoniare.
All’esito, la Corte del rinvio aveva, anzitutto, ritenuto di non procedere all’esame della piccola A. e di non disporre un’indagine psicodiagnostica, nella convinzione che, dato anche il tempo trascorso dai fatti, non potessero ragionevolmente attendersi significativi contributi all’accertamento della verità da tale attività istruttoria, peraltro non sollecitata da alcuna delle parti. Tanto premesso, la Corte stessa aveva, poi, ripercorso le diverse fasi che avevano caratterizzato le vicende oggetto del procedimento, sottoponendo ad esame critico le dichiarazioni ed i comportamenti dei personaggi coinvolti, a partire, ovviamente, dai bambini presunte vittime degli abusi, ed era giunta a concludere che, pur in presenza di elementi a carico di notevole spessore, l’esame complessivo del quadro probatorio non fosse tale da consentire di superare ogni ragionevole margine di dubbio circa l’attribuzione all’imputato delle condotte delittuose contestate.
6.1. Particolare attenzione era stata riservata dalla Corte d’Appello alla narrazione della piccola A., che si era ritenuto fosse caratterizzata da una serie di racconti incredibili e frutto di fantasia, come quelli relativi ad incontri orgiastici organizzati fuori dalla scuola, in ragione del contesto spazio-temporale nel quale erano stati collocati e del fatto che tali racconti erano, peraltro, rimasti privi di riscontro. I giudici del rinvio avevano anche sostenuto che, se è pur possibile ritenere che ai racconti fantastici si siano accompagnate narrazioni di fatti realmente accaduti, ben difficile sarebbe stata la demarcazione tra la fantasia e la realtà. Mentre era apparso sorprendente il fatto che i gravi abusi riferiti non avessero lasciato tracce nè sul corpo della bambina nè nel suo animo, non avendo le maestre ed i genitori rilevato nella piccola atteggiamenti particolari.
6.2. Quanto al ruolo assunto dai genitori della bambina, la Corte territoriale, pur confermando i positivi giudizi di equilibrio e correttezza già espressi, sul conto degli stessi, nelle precedenti sentenze, aveva rilevato come il Tribunale e la Corte di Appello, nella decisione annullata, non avessero considerato l’eventualità che i due coniugi, in perfetta buona fede, avessero raggiunto l’intima convinzione che la figlia avesse subito realmente gli abusi descritti ed avessero iniziato ad interrogarla con modalità suggestive, tali da indurla a riferire circostanze da loro stessi supposte. Per quel che concerne, poi, i malesseri manifestati da A. in tempi precedenti rispetto all’insorgere dei sospetti (nervosismo, irritabilità, rifiuto dell’asilo e dei giocattoli, incubi, sensi di colpa accompagnati da pugni sulla sua persona), la Corte del merito aveva rilevato che, seppur preoccupanti, essi avrebbero potuto trovare spiegazioni diverse da quelle ipotizzate dall’accusa e risiedere, cioè, nella diminuita attenzione degli insegnanti (conseguente al passaggio al secondo anno di asilo) e della stessa madre (che aveva ripreso, sia pure part-time, l’attività di lavoro). Neanche soccorrevano con carattere di decisività, secondo la Corte territoriale, gli esiti della perizia perchè basata, non sull’analisi diretta della bambina bensì, sui sintomi segnalati dal genitori.
6.3. La sentenza assolutoria, inoltre, aveva ritenuto che neppure ai racconti degli altri minori potesse attribuirsi carattere di certezza, ritenendo legittimo il sospetto che si fosse trattato di un vero e proprio “contagio” psicologico, esploso non appena si era sparsa la voce degli abusi, che aveva indotto i genitori di altri scolari ad indagare sui propri figli al fine di accertare se essi ne fossero rimasti vittime. Indagine avviata anche da alcune maestre dell’asilo con modalità ritenute non adeguate, che avevano provocato le confidenze di taluno dei bambini, in relazione alle quali sarebbe stato legittimo il dubbio di una suggestione indotta dalle interroganti. Con riguardo agli altri bambini coinvolti, di cui erano stati segnalati atteggiamenti inusuali, inizialmente trascurati dai genitori (rifiuto di andare all’asilo, incubi, dimagrimento, comportamenti aggressivi, tentativi di toccare il padre ed il fratello nelle parti intime), la Corte territoriale aveva ritenuto che tali comportamenti, per una parte, potessero essere spiegati dal passaggio da un corso all’altro mentre, per altra parte, specie quelli “sessualizzati”, con la normale crescita psicosessuale dei bambini. In conclusione, la evidente fantasiosità di alcune narrazioni, in particolare attribuite ad A. ed a G., l’assenza di riscontri, il dubbio che i racconti più credibili dei bambini fossero stati inconsapevolmente indotti dalle suggestive modalità di interrogazione utilizzate dai genitori e, in qualche caso, dalle maestre, la psicosi degli abusi che si era sparsa nella scuola allorchè si era avuto sentore di episodi di violenza sui bambini, le incerte conclusioni dei periti, che, peraltro, non avevano sottoposto ad analisi, per varie ragioni, alcuni dei bambini coinvolti, avevano indotto la Corte territoriale ad emettere una sentenza assolutoria.
La qual cosa ha finito per cancellare, come un colpo di spugna, due premesse date per scontate (persino dalla difesa dell’imputato) relativamente alla obiettività, attendibilità e genuinità degli interventi degli altri adulti ed alla capacità a deporre dei minori, attestate anche dai periti… I giudici di secondo grado, reiterano, così, il sospetto che le rivelazioni progressive fatte dalla piccola A., di cui la madre aveva tenuto nota in un diario, fossero state solo il frutto di un “assecondare” della bimba le preoccupate domande della madre (visto che se ne ignora il contenuto) e del padre (giunto a stilare dei disegni sulla base delle indicazioni della bambina), sì da poter dubitare di essere in presenza di un “un’opera interpretativa delle affermazioni di A.”. I giudici hanno poi, ribadito il convincimento che gli argomenti a sfondo sessuale fossero stati trattati dalla bambina solo dopo che i genitori, a seguito dell’incontro con la neuropsichiatra dott.ssa P., erano stati indirizzati nel sospetto che i malesseri della bambina fossero conseguenza di abusi sessuali… i giudici di appello….hanno semplicemente ignorato le critiche che già in precedenza erano state rivolte all’altra sentenza in cui erano stati sviluppati questi medesimi argomenti cui, però, quei giudici di legittimità avevano obiettato osservando, ad esempio, che la precedente Corte d’Appello (che aveva usato lo stesso argomento) non aveva neppure considerato “sia pure per escluderla, la possibilità che proprio l’intervento della neuropsichiatra, che aveva indicato ai coniugi le migliori tecniche di interrogazione della bimba, poteva aver loro consentito di avviare un più proficuo dialogo con la figlia per indurla a confidarsi fino a rivelare progressivamente i racconti più scabrosi” (f. 20). Ma l’esempio più evidente di come il percorso argomentativo dei giudici di merito sia stato unidirezionale lo si rinviene nel modo in cui essi hanno sottovalutato il dato obiettivo – da essi stessi riferito – (f. 46) che la piccola A. “quando ha dovuto dare un nome al soggetto che le creava disagio e che, fino ad allora aveva indicato come la sua ombra… aveva parlato di un maschio…
magro, nanerottolo, con occhiali verdi, baffi neri e pizzetto nero”.
A tale riguardo, il ricorrente sostiene che tale descrizione “corrisponde perfettamente alle fattezze fisiche dell’imputato”….gli stessi giudici di appello non hanno speso una parola per negare che ciò che sostiene il P.G. ricorrente sia vero…. Il percorso motivazionale prosegue in modo sempre meno coerente nel momento in cui gli stessi giudici attestano che nella scuola, a parte G., “l’unico maschio che svolgeva compiti vicini ai bambini era proprio B.” ma si affrettano a sottolineare che, quest’ultimo non era “ben visto” dai genitori… le incertezze sulla individuazione del nome di B. ed il suo stesso apparire presentano una precisa e logica chiave di lettura del tutto trascurata dai giudici di merito i quali, in primo luogo, non hanno considerato che proprio le esitazioni possono essere “sintomatiche della assoluta obiettività” dei genitori di A. e, comunque, non hanno spiegato come mai, nonostante il “pregiudizio” di cui si fa comunque carico ai signori F., il nome di B. sia emerso per la prima volta “durante la visione di un cartone animato e dunque non in occasione delle interrogazioni dei genitori” (f. 20). Il vero è che, come già avevano sottolineato i giudici che avevano pronunciato l’annullamento con rinvio – commentando argomentazioni che la presente sentenza ha meramente replicato – il tema della attendibilità dei racconti fatti dalla piccola A. cosi come venuto a conoscenza attraverso le parole dei suoi genitori è stato trattato e concluso dai giudici del rinvio con un approccio, per così dire di tipo “autistico”. In altri termini, pur dando atto (perchè obiettivamente esistenti) delle conclusioni peritali e delle inquietanti emergenze dei racconti di A. e degli altri minori, essi sono, poi, pervenuti – immotivatamente – ad un giudizio di sostanziale inattendibilità degli stessi. …Anche questo collegio, infatti, conviene con i precedenti giudici di questa S.C. sul fatto che la descrizione, da parte di A. di atti sessuali tanto crudi e specifici, “se si esclude che abbia avuto origine da un’esperienza effettivamente vissuta dalla bimba, non potrebbe che essere il frutto di suggestioni determinate non tanto da un errato approccio al problema da parte dei genitori, quanto di una loro fantasia perversa”. Di ciò non sembrano essersi fatti carico nemmeno i presenti giudici di rinvio che, perseverando, hanno ignorato il preciso invito loro rivolto a spiegare come fosse stato possibile che una bambina che viveva in un ambiente sano (come indiscutibilmente attestato sin dalla sentenza di primo grado), seguita da genitori che i periti hanno concordemente giudicato positivamente, fosse stata in grado di descrivere una scena dai significati chiari per un adulto aduso a conoscere le vicende di un atto sessuale ma inimmaginabile da parte di una bimba in tenera età come era A., se non per averla personalmente vissuta…
Nel racconto della bambina, infatti, B. si era abbassato i pantaloni e le mutande, scoprendo un “pisello enorme che sembrava un serpente…, più grande di quello del papà”; egli aveva, poi, con delle forbici, “tagliato il serpente che aveva attaccato al pisello”.
Il racconto della bambina era stato corroborato da un foglio che poi ella aveva arrotolato formando una specie di tubo che si era portato alla bocca, mimando quello che l’uomo le avrebbe fatto. Sorprendente è anche la precisazione che “in bocca il serpente era molliccio e sembrava che si sciogliesse”. I precedenti giudici di legittimità, al riguardo avevano censurato l’affermazione di inverosimiglianza fatta dalla Corte di Appello sul rilievo che non sarebbero state comprensibili le ragioni del taglio del preservativo e dell’uso stesso del profilattico e neppure la descrizione del pene che, essendo presumibilmente in erezione, era stato invece descritto come qualcosa di “molliccio che si scioglieva”. Nell’occasione questa S.C. aveva obiettato che non erano state considerate una serie di possibilità: “che il taglio del preservativo potesse riferirsi alla confezione al cui interno esso era raccolto, che l’uso dello stesso fosse determinato dall’esigenza di non lasciare sulla bambina tracce organiche dell’abuso, che la descrizione del pene molliccio, che sembrava che si sciogliesse, potesse riferirsi, nel racconto della bambina, alla fase finale dell’atto sessuale, allorchè il pene non era più in erezione, che l’impressione che lo stesso si scioglieva potesse rappresentare la descrizione della sensazione provata dalla bambina al momento dell’eiaculazione”. Orbene, di fronte a siffatte angolazioni prospettiche tese a criticare la inadeguatezza della interpretazione data ai fatti dai precedenti giudici di merito, anche nella sentenza qui in commento ci si imbatte in attestazioni di inverosimiglianza (f. 133 ss.) in questo caso connesse a mere “impressioni” del giudicante secondo cui, non essendo quelle parole il risultato di un patrimonio linguistico di un bimbo in così tenera età, si sarebbe stati al cospetto di mere “interpretazioni” della madre soggiungendosi che, sia pure inconsapevolmente, quest’ultima avrebbe finito per elaborare un siffatto turpe racconto. In via di mera ipotesi, la eventualità non può essere esclusa ma, per essere validamente sostenibile deve essere confortata, in primo luogo, da una precisa replica alle obiezioni già fatte ai giudici del rinvio circa il fatto che i genitori di A., davanti ai disturbi comportamentali manifestati dalla figlia nel mese di ottobre, secondo quanto emerge dagli atti, avevano seguito un percorso del tutto coerente rivolgendosi, inizialmente, ad un pediatra e, quindi, su consiglio del medico, ad una neuropsichiatra; secondariamente, la tesi dei giudici di merito non tiene in alcun conto l’intero contesto che è emerso dal processo anche attraverso le testimonianze delle maestre e dei genitori degli altri bambini. Nuovamente, i giudici d’appello, nella decisione qui in discussione hanno portato avanti la tesi della “suggestione collettiva” e del “contagio” ignorando, però, del tutto le obiezioni che ad essa erano già state rivolte da questa S.C. nella sentenza con cui era stata annullata quella precedente (che aveva sposato la stessa linea). Giustamente si era, infatti, sottolineato che, restando indubitabile la possibilità per la Corte del rinvio di manifestare un giudizio opposto a quello del primo giudice, ciò si sarebbe potuto – e dovuto – fare solo dopo un attento esame di tutti i comportamenti e delle emergenze processuali che evidenziavano un sicuro giudizio positivo dei periti anche rispetto agli altri genitori. A convincere definitivamente della incongruità ed illogicità della motivazione con cui i giudici di appello hanno definito la vicenda, soccorrono le reali assenze di risposte ai gravi malesseri denunciati da A. e da altri bimbi e le risposte piuttosto banalizzanti e frutto di un giudizio di soggetti certamente non esperti del settore… I giudici di merito non hanno dato risposta ad un semplice interrogativo posto loro dalla precedente decisione di questa S.C., e cioè, come sia stato possibile che “nello stesso contesto temporale, bambini in tenerissima età, tranquilli e dediti ai giochi tipici dell’età, appartenenti ad ambienti familiari sani e consapevoli, privi di tensioni o problematiche particolari, se si eccettua quello del piccolo W., orfano di madre, e tuttavia attentamente seguito dal padre, appartenenti alla stessa scuola, ma a sezioni diverse, abbiano improvvisamente iniziato: a) a tenere comportamenti, del tutto simili tra loro, strani ed anomali rispetto a quelli pregressi, che segnalavano, evidentemente, condizioni di chiaro disagio (ad un certo punto, tutti i bambini hanno manifestato insonnia, aggressività anche verso sè stessi, rifiuto della scuola, incubi, paure prima mai manifestate); b) a raccontare storie a sfondo chiaramente sessuale che, in ragione della loro età, non potevano far parte del loro patrimonio di esperienze; storie che, pur differenti in talune parti, in altre presentavano chiare affinità, in quanto caratterizzate da palpazione e manipolazione delle parti intime, baci con la lingua, rapporti orali, ovvero vaginali o anali, quantomeno tentati; c) a riferire di minacce ricevute per non denunciare gli abusi; d) a manifestare comportamenti chiaramente sessualizzati, atteggiamenti, cioè, di valenza sessuale, del tutto impropri in bambini di così tenera età ( S. palpeggiava e baciava sulla bocca la madre e pretendeva di farle la pipì addosso, A. sovrapponeva due pupazzi, maschio e femmina, ed ansimava riproducendo un rapporto sessuale, W. palpeggiava gli organi genitali del padre e gli chiedeva di dargli la lingua e di fare l’amore, la madre di G. rilevava un’infiammazione nella zona genitale della figlia, oltre alle cicatrici in zona anale, la madre di R. notava lividi al sedere, alle gambe ed alle braccia della figlia)”. Si potrebbero, poi, soggiungere ulteriori dettagli obiettivi evidenziati dal ricorrente concernenti il rinvenimento sia nella cantina della scuola (indicata dai bambini come uno dei luoghi in cui erano stati condotti) che nell’armadietto del M., di indumenti e parrucche la cui presenza troverebbe una spiegazione nei racconti dei bambini (secondo cui le persone che avrebbero fatto con loro le cose denunciate si sarebbero camuffate da pagliacci) ma che è stata semplicisticamente liquidata dai giudici con l’ipotesi che si trattasse di oggetti portati a scuola dai familiari per travestimenti periodici senza che, però, la spiegazione si attagli, ad esempio, anche al pezzo di “pongo” modellato a forma di fallo che, come chiosa il ricorrente “non aveva alcuna ragione di trovarsi in una scuola materna ma che assume un inequivoco significato nel contesto dei racconti dei bambini”. Risulta, quindi, altamente illogico da parte dei giudici di merito non avere commentato la cosa in alcun modo ma essersi limitati a spiegazioni banalizzanti e, comunque, inadeguate…la sentenza impugnata riflette il vizio originario – segnalato dal ricorrente – di non avere tenuto conto delle precise indicazione che le erano venute dalla sentenza con cui questa S.C. le aveva rinviato gli atti ed, anzi, di essere incorsa esattamente nel medesimo errore denunciato dalla Corte per la precedente decisione da essa annullata, di avere operato, cioè, solo una lettura parziale dei contesti probatori relativi a ciascuno dei minori coinvolti finendo con il “frazionarli e parcellizzarli, isolando i diversi episodi per rilevarne incongruenze ed inverosimiglianze, contraddizioni e dubbi che un più complessivo esame degli elementi probatori acquisiti avrebbe potuto chiarire ovvero dissipare”…. Risulta nuovamente incongruo che i giudici di merito nel commentare i racconti dei bambini a proposito del luogo in cui sarebbero stati condotti (la “trappola” di cui parla la piccola G.) – corrispondente effettivamente ad un passaggio scomodo e normalmente non utilizzato di cui la polizia aveva accertato l’esistenza, “una grata sollevata la quale e scendendo alcuni gradini si accedeva al piano interrato, composto dalla cantina, dal locale caldaia e da un piccolo locale da cui si poteva accedere all’asilo o alla casa del custode” – si siano diffusi nel commentare la scarsa utilità e sicurezza di un simile passaggio ma non abbiano risposto all’unico argomento sottolineato dalla S.C., consistente nell’interrogativo su come avesse potuto, una bimba di 4 anni, essere al corrente di quel passaggio e del posto cui esso conduceva e che ella aveva descritto con tanta dovizia di dettagli”.
1) se, nel vagliare l’attendibilità della testimonianza del minore di tenera età, si possa fare ricorso alle testimonianze de relato dei genitori solo quale criterio sussidiario, una volta valutata la capacità del minore a rendere dichiarazioni genuine, cioè non inquinate da interventi suggestivi degli adulti di riferimento (compresi gli stessi testimoni indiretti), sia da entrambi i fattori, ovvero se, nel vagliare l’attendibilità della testimonianza del minore di tenera età, si debba tenere primariamente conto della testimonianza de relato dei genitori, che assume particolare valore probatorio per il rapporto diretto di consequenzialità e contestualità con il fatto che è alla radice della sua deposizione;
2) se, nel vagliare l’attendibilità della testimonianza del minore di tenera età, non possa trovare spazio la valutazione psicologica peritale compiuta sull’asserita presenza di sintomi psicologici, astrattamente indicativi di abusi, senza che vi sia un esame diretto del minore da parte del perito, tenendo conto che la risposta allo stress è aspecifica, per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale sia da altre cause, ovvero se, al contrario, possa trovare spazio la valutazione peritale compiuta sulla presenza di sintomi rivelatori di un pregresso abuso sessuale anche laddove tale valutazione si basi sulla testimonianza dei genitori e avvenga in assenza di un’osservazione diretta del minore.
Il ricorrente ha proposto, altresì, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. con riferimento all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono correttivi alla possibilità delle parti di impugnare sine die le sentenze emesse a seguito di rinvio dopo annullamento ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., non prevedendo in particolare l’obbligo per il giudice di cassazione di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi tesi a far valere una diversa pronuncia di legittimità sulla medesima violazione di legge su cui in precedenza altra sezione della Corte di Cassazione si era già espressa;
La Corte, lamenta il ricorrente, ha del tutto omesso la disamina dell’esito della rinnovazione, dando per scontata la capacità testimoniale di A., ed ha totalmente omesso la disamina circa la genuinità dei racconti dei minori, trascurando le obiezioni difensive sul punto. La motivazione sarebbe meramente apparente e illogica con riferimento alle altre prove dichiarative dirette assunte dai minori in incidente probatorio, essendo stata omessa ogni disamina sulla autonomia testimoniale dei minori e sulla loro intrinseca credibilità, senza alcuna distinzione tra parti dei singoli narrati ascrivibili alla fantasia e parti che, pure verosimili, non hanno trovato rispondenza concreta, relegando tutto ciò che non ha trovato riscontro nel settore della fantasia, simbologia, immaturità del minore. Con riguardo alla valenza probatoria attribuita alla perizia psicologica sui cosiddetti disagi dei minori, il responsabile civile aveva proposto specifiche doglianze sostenendo l’inaffidabilita del responso per mancanza di scientificità dei presupposti ed incoerenza del metodo di applicazione; in questa sede deduce la totale pretermissione delle deduzioni difensive, essendosi limitata la Corte ad accettare le conclusioni dei periti, basate sulla analisi di sintomi o di disagi non osservati clinicamente ma riferiti dai genitori, nonostante gli stessi periti avessero affermato che gli adulti depositari potessero aver inquinato la spontaneità delle narrazioni dei minori. Con riferimento a R.C., la Corte territoriale avrebbe mutuato regole e principi di indagine psicologica al di fuori dell’apporto peritale, trascurando le deduzioni effettuate dal ricorrente a proposito dell’epoca in cui la notizia di abusi alla scuola era stata ufficializzata nel quartiere per effetto della notifica degli atti giudiziari e per le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale, che coinvolgevano l’intera comunità in concomitanza con l’effettuazione degli atti peritali. Vizio di motivazione in relazione al capo b). Il ricorrente deduce che nella sentenza non vi sia alcuna traccia dei narrati di A. e G. sulle case in cui le bambine sarebbero state portate, nè vi è traccia dell’acconta di abusanti che avrebbe predisposto locali prossimi all’edificio scolastico, autovetture per il rapido prelevamento dei bambini, precisi piani operativi per tenere conto degli orari di presenza dei bambini, del turno di lavoro del prevenuto, delle improvvise visite dei familiari, delle possibili intromissioni di altro personale scolastico, nè degli abusi sessuali di gruppo corredati di suggestioni verbali o scenografiche e rituali allestiti con lo scopo di alimentare il mercato delle immagini pedopornografiche. L’esito assolutorio sulla corresponsabilità della ausiliaria P. ha determinato la scomparsa dalla imputazione sia dei possibili concorrenti intranei sia dei presunti concorrenti esterni e dei luoghi prossimi o attigui alla materna indicati nella contestazione come teatri degli abusi, cancellando un pilastro fondamentale dell’accusa. La sentenza impugnata, si assume, ha risolto la questione sopprimendo ogni necessità di verifica dei tempi, luoghi, spazi, al contempo affermando la possibilità di sopravvivenza del concorso inizialmente configurato con motivazione illogica. Il criterio enunciato a sostegno della valutazione circa la credibilità del racconto degli abusi patiti dai minori, fondato sulla enucleazione dei dati essenziali dei racconti che si saldano e spiegano i sintomi senza esaminare tutti i particolari della ricostruzione dei piccoli per trame ragioni di inverosimiglianza del nucleo del racconto, rappresenta secondo il ricorrente violazione del principio enunciato dalla Corte di legittimità. La Corte avrebbe omesso di motivare l’asserita mancanza di vigilanza da parte delle maestre a fronte di corpose produzioni e deduzioni difensive sottoposte all’attenzione del giudice dal responsabile civile, che aveva peraltro documentato come alla data del 27 aprile 2001 l’accesso esterno all’appartamento del custode, luogo cui i bambini sarebbero stati condotti, era stato chiuso, già deducendo nell’atto di appello che la ricognizione dell’altro locale, ossia la cantina, era opera di R.G. e non di S.G. e non era in alcun modo ricollegabile ad A.. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha attribuito agli oggetti rinvenuti in cantina, ossia gli indumenti ed un pezzo di pongo, valore univoco di riscontro alle dichiarazioni dei minori, pur trattandosi di dati equivoci;
inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 604 c.p.p., comma 4, per violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 83 c.p.p., comma 5 e artt. 178 e 179 cod. proc. pen., art. 24 Cost., comma 2, art. 112 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce di aver censurato nell’atto di appello le inconsuete modalità liquidatorie del danno per nucleo familiare e di aver riproposto con il ricorso tale motivo, rigettato dalla Corte di appello e ritenuto assorbito dalla Suprema Corte;
Il ricorrente censura l’assenza di motivazione da parte del giudice del rinvio in ordine alle doglianze mosse ai criteri assunti per la liquidazione del danno, alla genericità dei parametri adottati dal Tribunale ed alle modalità con le quali il Tribunale era pervenuto alle liquidazioni, assemblando in via equitativa ed omnicomprensiva danni patrimoniali e non patrimoniali di genitori e figli.
Motivi della decisione
1.1. Considerazione preliminare è che, nel caso in esame, l’annullamento della sentenza in precedenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano era intervenuto per accertato vizio di motivazione. S’impongono, in relazione a tale premessa, alcune considerazioni in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice di merito in fase di rinvio a seguito di annullamento per vizio della motivazione.
1.2. La finalità è di verificare l’ammissibilità dei motivi di ricorso con i quali si lamenta che il giudice del rinvio non si sia attenuto alle questioni di diritto già decise dalla Corte di Cassazione nei precedenti giudizi rescindenti.
1.3. In generale, a proposito dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito in fase di rinvio, secondo l’art. 628 c.p.p., comma 2, tale sentenza può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte. Tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Corte Cost. n. 136 del 3/07/1972, n. 21 del 19/01/1982, n. 294 del 26/06/1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv.
230578).
1.4. Va, peraltro, ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità. In ragione di tale principio, risulta evidente l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel primo motivo del ricorso proposto dall’imputato a firma Avv. Gullotta, che fornisce un’interpretazione della norma nella sua attuale formulazione, in contrasto con il testo normativo e con l’interpretazione secondo “diritto vivente”, oltre che la sua irrilevanza nel presente processo, in cui tutte le pronunce di annullamento sono intervenute, sul punto concernente l’accertamento del reato, per vizio di motivazione.
1.5. E’, invero, ius receptum che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell’adempimento dell’obbligo della motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell’art. 627 c.p.p., comma 3, in ogni altro caso di annullamento (Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242; Sez. 1, n. 26274 del 6/05/2004, Francese, Rv. 228913). Ma occorre sgombrare il campo da un equivoco e chiarire cosa si intenda per quaestio iuris affermata nella sentenza di annullamento per vizio di motivazione.
Con specifico riguardo alla valutazione del fatto, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, a differenza di quando l’annullamento interviene per violazione o erronea applicazione della legge, non è vincolato alla valutazione dei fatti accertati nel provvedimento annullato ed è, anzi, chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato nel giudizio rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760). Con tale chiarimento si risolve, dunque, in senso negativo, la questione dell’ammissibilità di tutte le censure fondate sulla valutazione dei fatti che il giudice del rinvio avrebbe operato in difformità dal giudice di legittimità, non essendo tale valutazione vincolante per la Corte di Appello chiamata a riesaminare il materiale probatorio.
Con riguardo all’iter logico della decisione, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; in alcune pronunce della Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694). Il principio di diritto, si dice, è, in ogni caso, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490;
Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232019).
1.6. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del rinvio dall’annullamento per vizi di motivazione, che sembra delinearsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo enunciato la cosiddetta “trama” motivazionale, ma anche rilevato una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova;
d’altro canto, lo sviluppo dell’analisi di talune acquisizioni istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi della sentenza annullata, piuttosto che l’obiettivo di fornire al giudice del rinvio indicazioni vincolanti in merito all’apprezzamento del fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l’inammissibilità di quelle censure che si fondano sull’asserita violazione delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in merito ad una determinata valutazione del compendio istruttorio, non potendo vincolare il giudice del rinvio la lettura delle prove in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione.
1.7. Non può definirsi, in altre parole, come “questione di diritto nei termini ed ai fini indicati dall’art. 627 c.p.p., comma 3, l’enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poichè egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento. Non viola, pertanto, l’obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).
1.8. Nè rileva, come principio di diritto vincolante in quanto attinente alla violazione di legge, l’enunciazione in precedenti fasi di legittimità delle regole che presiedono all’acquisizione ed alla valutazione delle prove, come l’accertata violazione dei principi generali dettati dagli artt. 187-193 cod. proc. pen.. E’, infatti, opportuno ricordare che nel giudizio di rinvio sono operanti, per il giudice e per le parti, i limiti segnati dall’art. 627 c.p.p., comma 4, a norma del quale “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari”.
Collegando alla sentenza di annullamento l’effetto della irretrattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inammissibilità, la disposizione è unanimemente considerata quale puntuale applicazione delle preclusioni formatesi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio. In altre parole, il presupposto giustificativo della norma risiede nella particolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di Cassazione, già richiamata; il fondamento della disposizione di cui all’art. 627 c.p.p., comma 4, poggia, dunque, sulla definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa coessenziale, delle preclusioni che operano con riguardo al dedotto e al deducibile. Ne segue, come corollario, la necessità di ribadire il principio affermato dalla Corte, secondo cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità, ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle fasi del processo, anche in quelle di legittimità (Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979), antecedenti all’annullamento, non possono essere più fatte valere nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 10624 del 12/02/2009, Barbara, Rv. 242980).
L’intangibilità della decisione copre, dunque, non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro essendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell’interpretazione analogica della disposizione, ma nell’esplicitazione di una regola direttamente ricavata da un principio generale dell’ordinamento. Deve inferirsene che, nell’ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili (Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, n. m. sul punto; Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, Marine, Rv. 235274). Risultano, dunque, ulteriormente ridotti i limiti di ammissibilità delle censure concernenti la violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento per vizio di motivazione, non essendo deducibili, tra i vizi concernenti l’esame del compendio istruttorio, le inutilizzabilità verificatesi prima della sentenza di annullamento con la quale il giudice del rinvio è tenuto a confrontarsi.
1.9. Mentre, dunque, le questioni di diritto seguono il regime delle preclusioni e dei limiti di ammissibilità sopra delineato, le questioni che non siano state già decise dalla Corte delimitano, in definitiva, l’ambito di deducibilità del vizio di motivazione. Va rimarcato, in proposito, che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), a tale limite fungendo da contraltare, nel giudizio di rinvio, la regola dettata dall’art. 627 c.p.p., comma 2, secondo la quale “il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge”.
1.10. Più in generale, con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:
1.11. E’, inoltre, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti nè a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.
241907).
1.12. Pienamente applicabile al caso in esame è, poi, il principio in base al quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con i motivi d’impugnazione contro la sentenza medesima.
1.13. Si possono, dunque, enunciare alcuni principi qui rilevanti in tema di valutazione della prova dichiarativa ed in tema di valutazione della perizia. In primo luogo, i criteri di valutazione della prova testimoniale diretta non sono diversi dai criteri di valutazione della prova testimoniale indiretta o de relato, in relazione alla quale il codice di rito penale stabilisce esclusivamente un divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed un limite di utilizzabilità qualora non venga assunta, sebbene richiesta da una o più parti, la testimonianza della persona alla quale il testimone indiretto si sia riferito per la conoscenza di fatti, senza stabilire alcuna gerarchia tra i due tipi di dichiarazioni (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793; Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv. 254071;
Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 1, n. 39662 del 07/10/2010, Valpiani, Rv. 248478). Sono, comunque, utilizzabili le deposizioni de relato aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali ove all’esame di questi non si faccia luogo in ragione dell’accertamento di possibili danni, anche transeunti, alla sua salute, collegati all’assunzione dell’ufficio testimoniale (Sez. 3, n. 30964 del 11/06/2009, F., Rv. 244939), ovvero laddove la deposizione del minore si riveli sostanzialmente inutile, pur essendo lo stesso capace a testimoniare (Sez. 3, n. 13982 del 13/02/2008, U., Rv. 239911). Le dichiarazioni rese dal minore al perito sono, invece, utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell’incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto, giusta il divieto di cui all’art. 228 c.p.p., comma 3, e il disposto dell’art. 392 c.p.p., comma 1-bis e art. 398 c.p.p., comma 5-bis, (Sez. 1, n. 12731 del 11/01/2012, Spaccino, Rv. 252600).
Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente di parte (Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv.
258630). La valutazione del giudice in ordine all’attitudine a testimoniare e alla credibilità del minore vittima di reati sessuali deve essere fondata su una perizia ma, qualora tale accertamento non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, possono essere valorizzati altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 3, n. 1235 del 02/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254414), non essendo la perizia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità del minore, anche in tenera età, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della sua capacità a testimoniare (Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011, C, Rv. 251381).
1.14. Notori criteri specificamente concernenti la valutazione della testimonianza del minore in tenera età possono trarsi dagli studi scientifici, che considerano un errore valutare la testimonianza di un bambino in tenera età con i medesimi parametri che si utilizzano per l’adulto ed ascrivono particolare rilievo all’esame dei tratti salienti della personalità della coppia genitoriale, oltre che all’esame del comportamento del minore, sia nel contesto familiare e sociale sia in un contesto di gioco creato dall’esperto. Di comune esperienza è la massima secondo la quale la pur naturale fantasiosità del narrato di un minore in tenera età difficilmente consente al bambino di elaborare narrazioni di carattere sessuale, in quanto il bambino in tenerissima età non ha sull’argomento un substrato cognitivo da cui attingere il relativo materiale conoscitivo sul quale costruire il racconto di fantasia.
2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità tutte le censure tendenti, sotto l’egida dell’illogicità della motivazione, a proporre ed ottenere dal giudice di legittimità una diversa lettura del compendio istruttorie in base all’analisi di singole emergenze istruttorie già ampiamente vagliate dai giudici di merito, risolta secondo il libero e prudente convincimento del giudice, insindacabile ove sorretto da motivazione congrua, completa ed esente da manifesta illogicità.
Si tratta, in particolare, dei seguenti motivi del ricorso a firma Avv. Gullotta:
– secondo motivo. La censura sovrappone concetti tra loro ben distinti, ossia la valutazione dell’attendibilità delle testimonianze e la valutazione circa l’attendibilità del contenuto del racconto dei minori; distinguendo il contenuto della testimonianza diretta dei genitori con riguardo ai sintomi osservati nel comportamento dei figli dal contenuto della testimonianza indiretta dei medesimi genitori con riguardo ai racconti loro fatti dai figli, risulta evidente che nessuna illogicità è rilevabile nella motivazione della sentenza impugnata;
– terzo e quarto motivo. La sentenza impugnata si integra, con riferimento all’esame del diario scritto da L.B. e dell’audiocassetta dalla medesima registrata, con l’ampia ed esaustiva motivazione contenuta a proposito di queste acquisizioni istruttorie e, più diffusamente, a proposito dell’intrinseca credibilità di L.B., nella sentenza di primo grado (pagg. 39-56), alla quale la Corte territoriale ha ripetutamente fatto riferimento (pagg. 14, 19), aggiungendo (pag. 32), che la madre di A. non potesse aver veicolato un contagio dichiarativo in quanto “era pacifico non fosse al corrente di alcuna delle dichiarazioni degli altri piccoli”. Nè la circostanza che nella sentenza non si sia fatta espressa menzione dell’elaborato tecnico di parte redatto dalla Prof.ssa M. o dell’esame critico del contenuto del diario rappresenta di per sè vizio di motivazione, laddove le articolate valutazioni circa il contenuto del diario e dell’audiocassetta già presenti nella sentenza di primo grado costituivano esaustiva e satisfattiva smentita degli argomenti portati dalla difesa a sostegno della tesi per cui la minore sarebbe stata suggestionata dalla madre; l’asserito travisamento della prova in merito alla data d’insorgenza dei sintomi dell’abuso nei comportamenti della minore contrasta, oltrechè con il dato incontestato per cui i genitori di A. si erano rivolti al medico in quanto preoccupati da tali sintomi, con il dato pacifico che la redazione del diario avesse avuto inizio alcune settimane prima del consulto con la dott.ssa P., su consiglio del pediatra contattato nel mese di ottobre 2001;
– quinto motivo. Anche tale motivo di ricorso propone una diversa valutazione della prova. Non contrasta con le emergenze istruttorie che la minore A. sia stata sottoposta a visita ginecologica nel maggio 2002 e che sia stato riscontrato uno stato di infiammazione sia della vulva che della regione ano-genitale; nè risulta manifestamente illogico aver posto in correlazione l’esito dell’esame medico con il fatto che la minore avesse subito toccamenti vari (pag.
23, in linea con analogo rilievo dato a tale emergenza istruttoria dal giudice di primo grado alle pagg. 29 e 116), chiedendosi al giudice di legittimità di effettuare una diversa valutazione dei dati istruttori in senso favorevole al ricorrente. La testimonianza dell’agente C. in merito a quanto riferitole dalla minore F.I., che secondo il ricorrente avrebbe smentito i racconti di A., è stata espressamente esaminata dal Tribunale (pag. 42), che ha riportato stralci di una testimonianza ben più articolata ( I. aveva riferito all’agente C. che A. le aveva confidato un segreto, ossia che B. la aveva sculacciata nella cantina della scuola), rimarcando anche che in sede di incidente probatorio F.I. avesse riferito che A. le aveva confidato che c’era un bidello che le faceva paura. Tale testimonianza, come del resto altre risultanze istruttorie, è stata poi tralasciata dalla Corte di Appello, che non ha però trascurato di osservare come “singole discrasie o possibili fantasie sono del tutto connaturate alle caratteristiche psicologiche delle fonti” (pag. 34), in consonanza con i criteri di valutazione delle dichiarazioni del minore in tenera età sopra richiamati al punto n. 1.14;
– sesto motivo. Si tratta di censura che presuppone come note le date dei singoli abusi perpetrati nei confronti di ciascun minore, in contrasto con l’ampiezza dell’arco di tempo al quale sono riferibili i fatti descritti nelle sentenze di merito, da tale inesatto presupposto desumendosi la decisività di un dato istruttorio, ossia l’assenza del minore C.W. da scuola nel periodo (OMISSIS), che, invece, risulta non dirimente, anche alla luce della datazione dei primi sintomi di disagio riferita dal padre (pag. 74 sentenza di primo grado). Si tende ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze istruttorie laddove si deduce l’omessa menzione della testimonianza del padre del minore in merito ai buoni rapporti di W. con il M., ossia di una prova tanto meno determinante quanto più si osservi che si tratta di acquisizione istruttoria omessa unitamente a quella relativa alla testimonianza della zia paterna del minore in merito al diverso comportamento manifestato dal bambino (pag. 75 sentenza di primo grado);
– settimo motivo. Si tratta di censura nella sua globalità incentrata su una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. E’ sufficiente osservare, in proposito, che non risulta manifestamente illogica l’affermazione secondo la quale si ritiene plausibile che i genitori di un bambino con “chiari e persistenti problemi di linguaggio tanto da comunicare con la madre secondo un alfabeto a loro riservato si siano ricordati di alcuni sintomi di disagio diversi da quelli precedenti solo dopo aver saputo dei problemi insorti nella scuola materna dai genitori di A., avendo la Corte territoriale espressamente motivato (pag. 21) per quali ragioni ritenesse la condotta dei genitori di F.S. libera da suggestioni;
– ottavo motivo. Nella sentenza, contrariamente a quanto si deduce con il presente motivo, si richiama (pag. 34) la circostanza che i sintomi di disagio manifestati dalla minore R.C. non erano stati, prima delle rivelazioni, così eclatant da allarmare i genitori, traendo dalla spontaneità delle rivelazioni un giudizio di attendibilità delle stesse. La censura si fonda sulla parcellizzazione di una ben più ampia serie di acquisizioni istruttorie nel loro complesso richiamate con completezza nella sentenza di primo grado e valutate in una visione unitaria, con specifica replica ad analoghe deduzioni difensive già prospettate in primo grado (pagg. 97-102);
– nono motivo. E’ una censura in cui si propone una diversa lettura dei dati istruttori concernenti la minore S.G. al fine di avvalorare l’inverosimiglianza del narrato riferito dalla madre, laddove i giudici di merito hanno diffusamente e congruamente spiegato le ragioni per le quali la minore ed i genitori potessero ritenersi attendibili, rimanendo preclusa alla Corte di legittimità la valutazione circa la maggiore o minore plausibilità di un giudizio, valutativo del compendio istruttorio non manifestamente illogico nè, contraddittorio;
– decimo motivo. Si deduce come travisamento della prova un’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in particolare la frase “Era capitato che si addormentasse improvvisamente in classe” che risulta pienamente coerente rispetto alle risultanze istruttorie, nè risulta contestato quanto riportato in proposito a pag. 87 della sentenza di primo grado;
– undicesimo motivo. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe dato conto dei criteri utilizzati per distinguere i fatti veramente accaduti dalle parti fantasiose del narrato della minore S.G., ma si tratta di doglianza che confligge frontalmente con i criteri valutativi delle dichiarazioni del minore in tenera età indicati al punto n. 1.14, con la spiegazione fornita dalla Corte territoriale a pag. 36 a proposito della necessità per la minore di sopperire con la fantasia nel descrivere luoghi solo occasionalmente frequentati, nonchè con i numerosi elementi di riscontro indicati nelle sentenze di merito, in particolare la presenza di sintomi giudicati dagli esperti compatibili con i riferiti abusi, le dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, le cicatrici riscontrate nella zona anale (pag.
86 sentenza di primo grado); l’asserito travisamento della prova, oltre a riguardare un punto non decisivo, si risolve a ben vedere in una doglianza per travisamento del fatto, inammissibile in quanto tale;
– dodicesimo motivo. La censura, in fatto, sembra ignorare quanto chiarito dalla Corte di Appello a pag. 31 della sentenza, ove si legge “come è inevitabile in bimbi di tale età, i racconti dei fatti realmente accaduti erano riferiti con frequenti ricorsi alle simbologie che ciascun bimbo si era creato ed erano arricchiti da particolari certamente fantasiosi, per cui inevitabilmente ci si doveva ricondurre al nucleo essenziale del racconto ed alle più evidenti sovrapposizioni rinvenibili nelle ricostruzioni dei diversi bambini”, così dando atto dell’avvenuta cernita di quelle parti delle narrazioni di ciascun minore che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri bambini;
– tredicesimo motivo. Palese la non decisività dell’elemento istruttorio asseritamente travisato, laddove si tratta di minore ( N.R.) che ha rivelato l’abuso prima alle insegnanti che ai genitori. Il giudizio secondo il quale le maestre si sarebbero limitate a sollecitare il racconto e l’individuazione di un locale da parte dei bambini non esclude quanto dedotto dal ricorrente, nè tradisce alcun travisamento della relativa prova;
– quattordicesimo motivo. Nel ricorso si deduce, in patente contrasto con quanto riportato in entrambe le sentenze di merito (pagg. 35-37 sentenza di appello; pagg. 37, 56, 77, 87 ss., 99 sentenza di primo grado), che i minori non avrebbero rivolto alcuna accusa specifica di natura sessuale nei confronti del ricorrente, evidenziando esclusivamente alcune risposte estrapolate dal contesto e, dunque, parcellizzate, per sostenere una diversa interpretazione della prova, non consentita al giudice di legittimità.
2.2. Si tratta, altresì, dei seguenti motivi del ricorso a firma Avv. Scalvi:
– primo motivo, inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente parte dal presupposto che il giudice di legittimità avrebbe richiesto l’esame analitico delle dichiarazioni dei minori, in contrasto con il testo della sentenza di annullamento, trascurando in ogni caso che il giudice del rinvio ha fatto espresso richiamo, condividendole, alle analitiche argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza di primo grado. Deduce, peraltro, che la sentenza di primo grado sarebbe stata annullata dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, come è evidente, non ha invece comportato la regressione del processo ad un grado antecedente quello di appello;
– ottavo motivo. La questione proposta con tale motivo di ricorso non attiene alla violazione di un principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione Penale ma, in ipotesi, ad una questione non decisa dal giudice di legittimità. Ma, con particolare riguardo alla norma contenuta nell’art. 628 c.p.p., comma 2, secondo la quale la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata “soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione”, il principio di preclusione e la stessa logica del sistema delle impugnazioni sopra enunciata, in virtù della quale viene a formarsi un giudicato che si definisce progressivo sulle questioni non dedotte, impongono di chiarire che si debba trattare in ogni caso di punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati, ovvero di elementi che, aggiungendosi ad altri elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo, cioè tale da legittimarne una diversa lettura. Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere che il giudice in sede di rinvio abbia correttamente motivato il provvedimento, non esaminando censure del tutto estranee alle questioni dedotte nel precedente ricorso ed, in definitiva, coperte da giudicato. In ogni caso, non emergendo dal ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, se e in che atto del processo la parte abbia sollecitato l’audizione diretta del minore, si deve ritenere dirimente il principio secondo il quale “Sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 1, le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta” (Sez. 5, n.50346 del 22/10/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316).
2.3. Si tratta, altresì, dei seguenti motivi di ricorso proposti dal Comune di Brescia:
– secondo motivo. La censura si rivela in parte pretestuosa, a fronte della condanna del Comune di Brescia al risarcimento di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta a carico di M. B.E. nei confronti delle parti civili F. – L. e S. – K. proprio in ragione della determinazione dell’ammontare del danno subito dalle rispettive figlie minori. In ogni caso, per un completo esame della censura, va anche ricordato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione Civile in merito al fatto che, sebbene i crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito siano tra loro autonomi, nè tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine, tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di liquidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equitativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del quantum debeatur tra i creditori, nè rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione di cui art. 1226 cod. civ., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei creditori di provare l’ammontare del danno individuale (Sez. 1 civile, n. 19713 del 13/11/2012,Rv. 624572).
– quarto motivo. Dall’elenco dei motivi di ricorso sottoposti all’attenzione della Corte di legittimità avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 5/04/2006, è possibile rilevare che il Comune di Brescia si era limitato a censurare la pronuncia di liquidazione del danno con la seguente doglianza:
“erronea applicazione di legge in punto di singolare liquidazione del danno operata dal Tribunale in favore di “ciascun nucleo familiare”, anzichè operare delle suddivisioni pro quota :conseguentemente, contraddittore del Responsabile Civile era stato il “nucleo familiare”, cioè un soggetto non legittimato, che non era parte nel giudizio”. Occorre, ancora, delimitare l’ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, ribadendo i principi in precedenza espressi. La questione proposta con il presente motivo di ricorso sarebbe, infatti, ammissibile ove, pur non riguardando la violazione del principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione Penale, fosse riconducibile ad una questione non decisa dal giudice di legittimità. Si richiamano i medesimi principi già espressi nella trattazione dell’ottavo motivo del ricorso a firma Avv. Scalvi. Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per ritenere che il giudice in sede di rinvio abbia correttamente motivato il provvedimento, tralasciando di esaminare censure del tutto estranee alle questioni dedotte nel precedente ricorso ed, in definitiva, coperte da giudicato.
3.1. Nel ricorso si assume, poi, in contraddizione con l’assunto di partenza, che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di diritto enunciato nella prima sentenza di annullamento – si tratterebbe dunque secondo il ricorrente di principio non reiterato ma contrastante con quelli enunciati nelle successive sentenze di legittimità – concretato dalla necessità di anteporre l’accertamento della capacità a deporre dei minori alla valutazione circa l’attendibilità delle dichiarazioni de relato dei genitori, ed avrebbe, invece, fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sui sintomi comportamentali che i genitori avrebbero percepito a seguito delle prime accuse “girate” nella scuola, nonchè sulla valutazione che di tali sintomi avevano dato i periti psicologi; la sentenza impugnata neppure avrebbe esplorato la “tesi del possibile contagio dichiarativo tra i genitori, gli insegnanti e gli altri bambini presunte parti lese, nè avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 2007 aveva giudicato illogico ritenere possibile, quanto all’imputazione di cui al capo b), che rapimenti di minori posti in essere con simili modalità, con travisamenti di persone e nel corso di feste orgiastiche rumorosissime, fossero stati attuati nel corso dell’orario scolastico senza che nessuno potesse accorgersi della scomparsa dei bambini, reiterando argomentazioni già considerate manifestamente illogiche.
3.2. Le censure sono inammissibili laddove esulano dai limiti contemplati dall’art. 628 c.p.p., comma 2. Secondo i principi in precedenza enunciati, infatti, nel giudizio di legittimità conseguente all’impugnazione della sentenza di rinvio operano le preclusioni dettate dall’art. 627 c.p.p., comma 4, ed i limiti di ammissibilità previsti dall’art. 628 c.p.p., comma 2. Non è, infatti, condivisibile l’assunto per cui, tra le questioni di diritto alle quali il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi, sarebbero da annoverare quelle enunciate in sentenze di legittimità che, seppure emesse nell’ambito del medesimo processo, non riguardino i vizi rilevati nella sentenza che ha preceduto quella qui impugnata, tale vincolo essendo prospettabile, come chiaramente desumibile dall’art. 627 c.p.p., comma 3, unicamente in capo al giudice di rinvio che sia chiamato a decidere a seguito di un determinato giudizio rescindente e non anche in capo ai giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano deputati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso (Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, S., Rv. 256170). Sia sufficiente richiamare, in proposito, la giurisprudenza della Corte Suprema in tema di competenza del giudice del rinvio, al cui proposito si è osservato che il vincolo nascente dall’attribuzione di competenza al giudice di rinvio è correlato alla necessità di un iudicium rescissorium strettamente consequenziale ad una fase rescindente, nella quale la Corte di Cassazione ha proceduto all’annullamento con rinvio dello specifico provvedimento impugnato;
mentre non rilevano affatto le eventuali, precedenti e reiterate, statuizioni rescindenti pure adottate in sede di legittimità (Sez. 1, n. 13518 del 21/01/2010, Kacorri, Rv. 246824).
3.3. A tali considerazioni deve aggiungersi, onde evidenziare l’incongruenza delle censure rispetto ai fatti giudicati, quanto riportato a pag. 88 della sentenza di primo grado a proposito delle dichiarazioni rese dalla minore S.G. circa fatti avvenuti “una volta o due” in una casa lontana dalla scuola.
3.4. Palesemente infondata risulta, altresì, l’eccezione di giudicato interno con riguardo all’assoluzione della coimputata P., pronunciata con formula “per non aver commesso il fatto, dunque senza alcuna incidenza sul giudizio circa la sussistenza delle condotte contestate, non essendo in tal caso il giudice vincolato dalla pronuncia irrevocabile di assoluzione di un coimputato nel medesimo reato (Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante, Rv.259371;
Sez. 1, n. 18398 del 05/04/2013, Trebisacce, Rv. 255879).
Nella sentenza impugnata si precisa che le maestre della minore S.G. non avevano ritenuto di svolgere alcun approfondimento (pag. 17), mentre il riferimento a S.G. a pag. 18 della sentenza è, con evidenza, la ripetizione di un refuso del tutto ininfluente sulla tenuta argomentativa della pronuncia.
6.1. Va, in proposito, ribadito che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Qualora le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). La Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto, come detto, ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.
6.2. La sentenza di annullamento aveva, peraltro, espressamente indicato al giudice del rinvio il percorso argomentativo ritenuto essenziale ed è, qui, opportuno ribadire i punti salienti della traccia motivazionale segnata nel giudizio rescindente, al netto delle affermazioni esplicative della ratio decidendi e dei singoli sviluppi argomentativi che si limitavano a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, onde verificare se a tale traccia il giudice di rinvio si sia o meno attenuto:
6.3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha svolto la motivazione seguendo i seguenti passaggi:
Con la precisazione che, con riguardo alla minore A., l’osservazione diretta non era stata possibile per l’opposizione dei genitori (che temevano una ricaduta della piccola nella fase connotata dai più gravi disturbi), ma si erano esaminate le ulteriori emergenze, ossia il contesto e le dinamiche familiari e scolastiche e, soprattutto, il quadro (incontestato) dei sintomi ritenuti rivelatori del patito abuso. Va, in proposito, sottolineato che le censure mosse nel ricorso all’omessa validazione della perizia sotto un punto di vista strettamente scientifico si presentano generiche e non evidenziano quali sarebbero i vizi metodologici che la Corte avrebbe omesso di rilevare, rimanendo tali doglianze prive della specificità prevista a pena d’inammissibilità dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Con riguardo all’asserito ingresso nel processo del narrato della minore A. per il solo tramite dei genitori, la censura parte dall’infondato assunto che sarebbe illogico riproporre la valutazione operata dai periti in ordine all’attendibilità dei genitori, riproducendo il tema della veridicità del sintomo sulla base del narrato di questi ultimi. Richiamato quanto già osservato a proposito dell’inammissibilità delle doglianze che vorrebbero individuare il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio in un giudizio rescindente diverso da quello immediatamente precedente, giova chiarire che nella sentenza impugnata è stata fornita la descrizione del più ampio contesto, sia scolastico che familiare, in cui i diversi minori hanno manifestato i sintomi presi in esame dalle perite (pagg. 16-30), senza tralasciare di indicarne le fonti di prova. I sintomi esaminati nella perizia erano stati, infatti, riportati alle esperte da diversi adulti, ossia maestre, psicologi, genitori ed altri familiari, onde risulta di tutta evidenza l’infondatezza della censura fondata su un’illogica autoreferenzialità del narrato dei genitori. Con riguardo alle dichiarazioni del minore F.S., la Corte territoriale, preso atto delle difficoltà comunicative del bambino, ha correttamente posto l’accento sui sintomi comportamentali manifestati dal bambino nel tempo (pag. 20), evidenziando la non decisività della verifica del tipo di comunicazione fra il bambino e la madre.
In merito all’analisi dei sintomi manifestati dal minore C. W., non assurgono al vizio di manifesta illogicità della motivazione proposizioni delle quali viene evidenziata l’impropria struttura logica, come l’utilizzo di avverbi che indicano possibilità in aggiunta ad avverbi che indicano certezza.
Inconferente è, inoltre, l’assunto secondo il quale sarebbe illogico sostenere che gli sputi di A. confermerebbero un rapporto orale dalla stessa subito ed al contempo affermare che il M. avrebbe utilizzato un preservativo;
28-30) il giudizio peritale sul punto;
22), ritenendo che i dati istruttori fossero indicativi del fatto che le rivelazioni di A. erano state il frutto dello scandaglio doverosamente lanciato dagli adulti che ne avevano la responsabilità per comprendere, e possibilmente superare, gli inquietanti e gravissimi sintomi mostrati dalla bambina (pag. 24). A ciò si aggiunga, anche perchè richiamata dalla Corte di Appello, l’ampia, congrua ed esaustiva motivazione espressa, in replica ad analoghe censure, nella sentenza di primo grado (pagg. 47-57); alla medesima conclusione si perviene con riferimento al narrato dei genitori degli altri minori;
all’irrilevanza di singole discrasie ed inverosimiglianze presenti nei racconti dei minori rispetto al quadro che risultava da una visione d’insieme delle vicende che li riguardavano; all’assenza di elementi che facessero temere un contagio dichiarativo interno od esterno; ai riscontri forniti alle narrazioni dei bambini dall’individuazione all’interno del plesso scolastico di una cantina che alcuni di loro conoscevano, pur non essendo luogo di ordinaria frequentazione da parte loro, e dal rinvenimento, ivi e nei locali adiacenti, di mezzi di travestimento e di un pezzo di pongo descritto di foggia compatibile con un fallo. Giova, anche, richiamare quanto indicato (pag. 19) a proposito della scarsa vigilanza esercitata sui bambini durante l’orario scolastico;
7.1. La Corte ha espressamente richiamato, condividendole, le considerazioni fatte dal Tribunale, aggiungendo che i bambini avevano riferito di essere stati vittime di più di un adulto, illustrando anche le condotte che soggetti diversi dal M. avevano posto in essere ai loro danni ed esprimendo il giudizio che tali dichiarazioni costituissero parte del nucleo essenziale del racconto, al quale aveva fornito riscontro l’individuazione della cantina interna al plesso scolastico. La condivisione delle considerazioni del Tribunale non risulta inconciliabile con il richiamo alle non definite posizioni di due coindagati, avendo la Corte specificato, in linea con il giudice di primo grado, che la circostanza che non fossero stati individuati gli altri soggetti non escludeva la responsabilità del M. (si legga in proposito a pag. 132 della sentenza di primo grado “tali attività non erano commesse solo dal M., ma da più persone, la maggior parte delle quali rimaste sconosciute…”).
7.2. Secondo quanto congruamente indicato nella sentenza di primo grado, espressamente richiamata sul punto dalla Corte territoriale, l’individuazione dei luoghi esterni all’asilo non doveva essere necessariamente circoscritta ai due soli luoghi indicati nel capo d’imputazione ed, in ogni caso, l’espressione “aveva portato i minori…fuori della scuola materna, all’interno della abitazione di P.G. e dello Studio dentistico di S.V.” non doveva interpretarsi nel senso che i luoghi indicati costituissero l’unica specificazione del complemento “fuori della scuola”, indicando la presenza della virgola un’elencazione di più luoghi alternativi fra loro, di cui uno generico (fuori della scuola) ed altri indicati a titolo esemplificativo, ben potendosi ritenere inclusa nell’ipotesi accusatoria qualsivoglia altra abitazione, ivi compresa quella sovrastante l’asilo destinata ad alloggio del custode della scuola fino all’anno (OMISSIS) e collegata alla cantina della scuola tramite una scala interna all’immobile.
7.3. Per escludere il dedotto vizio di motivazione in merito ai luoghi degli abusi, giova rimarcare che l’assoluzione della coimputata P. non ha comportato l’irrevocabilità di accertamenti in fatto incompatibili con l’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati ascritti all’originario capo C). Si legge nella sentenza assolutoria emessa in data 5/04/2006 dalla Corte di Appello di Brescia, a proposito dell’incertezza delle risultanze istruttorie concernenti il riconoscimento dell’abitazione della P. quale luogo degli abusi da parte della minore S. G. “Con tali osservazioni non si intende…affermare la complessiva inattendibilità della bambina. Tuttavia non pare possibile sulla base di un’indicazione nominativa inspiegabilmente tardiva, non completamente spontanea e non corroborata da altre fonti di apprezzabile consistenza, affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che in casa P. venivano commessi gli abusi sessuali di cui al capo C) e che conseguentemente ella ne era corresponsabile”, da tanto desumendosi che nessun punto della decisione qui impugnata confligge con tale irrevocabile statuizione.
7.4. Contrasta con il testo della sentenza impugnata, che sul punto ha richiamato la motivazione del Tribunale, la censura di omessa motivazione in merito alle modalità con le quali sarebbero state consumate le condotte contestate al capo C), avendo i giudici di merito ritenuto provato che il M. avesse svolto un ruolo concorsuale consistente nell’attivarsi per il buon esito delle manovre di allontanamento dall’asilo e di rientro all’asilo dei minori (pag. 132), dopo aver descritto (pag. 110) il contesto scolastico come disorganizzato, con classi spesso prive di sorveglianti ed un allentamento della vigilanza nel pomeriggio, con un cancello posto sul retro della scuola, le cui chiavi erano nella disponibilità di tutti gli ausiliari, che restava aperto per un buon lasso di tempo e dal quale, per il tramite di una grata che era stata ben descritta da S.G., si accedeva al locale caldaia e, per esso, alla cantina. Da tale contesto la Corte territoriale, senza alcun riferimento a feste orgiastiche rumorosissime, ha desunto, con argomentazioni esenti da manifesta illogicità, la compatibilità dei dati istruttori acquisiti con l’ipotesi accusatoria, anche ove si fosse ritenuto che i fatti si fossero verificati in luoghi interni all’edificio scolastico ma diversi da quelli ordinariamente frequentati dai bambini.
Pur trattandosi di censura di natura processuale, l’esame di tale doglianza è stato qui inserito, per chiarezza espositiva, all’esito dell’esame delle censure concernenti il vizio di motivazione.
8.1. Premesso in fatto quanto già indicato al punto 7.2, in punto di diritto, occorre prendere le mosse dal principio enunciato dall’art. 521 cod. proc. pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l’imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
8.2. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez.U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
8.3. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, sta l’esigenza di assicurare all’imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell’imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l’accusa sia sfuggito alla difesa dell’imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale.
8.4. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, così come in maniera esente da illogicità è stato specificato dai giudici di merito, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 20/01/2009, Fioravanti, Rv. 242351; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv.
226796; Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv.213776; Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996, Martina, Rv. 206208; Sez. 6, n. 7955 del 21/04/1995, Innocenti, Rv.202572; Sez. 1, n. 2421 del 26/01/1995, Di Raimondo, Rv. 200474; Sez. 2, n. 5907 dell’11/04/1994, De Vecchi, Rv.
197831).
9.1. La Corte territoriale ha, dunque, fornito adeguata e congrua motivazione in relazione ai criteri seguiti per confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado. E’, in proposito, ricorrente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione di principio per cui l’obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto maggiore sia il divario tra la pena in concreto irrogata ed il minimo edittale, ma nel caso in esame la sanzione di fatto irrogata come pena base, pari ad anni otto di reclusione, è inferiore alla misura media edittale prevista dall’art. 609 octies cod. pen.; i giudici del merito, con la enunciazione dell’analisi dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., hanno in ogni caso qui assolto adeguatamente all’obbligo della motivazione (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988,dep. 5/1/1989, Spina, Rv. 180075).
9.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato sulla base della pluralità di condotte e della totale assenza di resipiscenza dell’imputato. La pluralità di condotte non era stata, a ben vedere, già valutata per determinare gli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione, riferibili alla pluralità di reati, mentre l’assenza di resipiscenza, ancorchè rilevata dalla condotta processuale, ben può essere distinta, come indice di valutazione negativa della personalità dell’imputato, dalle scelte difensive dal medesimo compiute (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606). A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferimento alla congruità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
10.1. La Corte territoriale ha richiamato, sul punto relativo alla liquidazione del danno in favore delle costituite parti civili, la motivazione svolta dal Tribunale, condividendone le conclusioni “a fronte dei gravissimi danni causati alle piccole vittime e ai genitori”.
10.2. La sentenza di primo grado aveva optato per una liquidazione equitativa del danno, inclusiva del danno patrimoniale per le spese sostenute, rimarcando la difficoltà di determinare nel suo esatto ammontare i danni subiti dai minori, costituiti da un’indicibile sofferenza, da spese per le terapie presso psicologi o nEuropsichiatri, da conseguenze che solo nel lungo periodo si sarebbero potute svelare nel loro grado, e dai loro genitori, descritti in termini di enorme sofferenza e, in alcuni casi, nella necessità di accantonare progetti personali di studio e di lavoro per aiutare i propri figli. Il Tribunale aveva, quindi, determinato l’ammontare delle somme liquidate, specificando che il loro differente ammontare dipendeva dal numero e dalla gravità dei fatti illeciti patiti, atteso che S.G. ed F.A. risultavano parti offese in entrambi i reati ascritti all’imputato, nonchè dalla costituzione dei genitori di N.R. solo quali titolari di responsabilità genitoriaie e non in proprio.
10.3. Si tratta, a ben vedere, di motivazione che non opera una netta distinzione tra singole voci di danno, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nè consente di sostenere che vi sia stata una duplicazione di voci risarcitorie, laddove l’origine di alcuni pregiudizi di natura non patrimoniale viene sottolineata a mero titolo esemplificativo.
10.4. Giova, a proposito, ricordare che all’istituto del risarcimento del danno da reato è attribuita la funzione di soddisfare in modo concreto l’interesse della vittima, rendendola partecipe del processo afflittivo-rieducativo, attraverso la mediazione attiva dello Stato.
Va anche ricordato che le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa (la n. R 83,7 adottata il 23 giugno 1983 e la n. R 85,11 adottata il 28 giugno 1985) già indirizzavano anche la nostra legislazione verso la valorizzazione della vittima. In particolare il punto B.5 della R(85) stabiliva che le decisioni discrezionali relative ai procedimenti penali non devono essere prese senza l’adeguata considerazione della questione della riparazione del danno subito dalla vittima, ivi compreso ogni serio sforzo dispiegato a questo fine dall’autore del reato, mentre il punto D.11 stabiliva che la riparazione deve poter costituire negli Stati membri sia una pena, sia una misura sostitutiva della pena, sia essere pronunciata in coincidenza con la commisurazione della pena.
10.5. Trattasi di un istituto in cui si può intravedere la crisi della concezione retributiva della pena, risalente agli anni sessanta, quando si è andata affermando l’idea che l’utilità della pena fosse legata all’efficacia preventiva, sia speciale sia generale, dalla stessa derivante. In altre parole, si è via via ritenuto che la pena si legittimasse soltanto se fosse idonea a distogliere i consociati dal delinquere ed a favorire il reinserimento sociale del reo. Tale concezione, che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 27 Cost., comma 3, ben si concilia con il principio di sussidiarietà o di extrema ratio della pena, oggi vivificato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nell’interpretazione dell’art. 7 CEDU, ed ha influenzato la concezione del risarcimento del danno e degli effetti penalistici di questo istituto. Nell’ordinamento italiano il risarcimento del danno, in base alla norma in esame, aveva esclusivamente funzione attenuativa della sanzione penale fino a quando, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 14) la riparazione del danno è stata configurata come causa estintiva del reato (art. 35), a condizione che il giudice, ritenga “le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”, secondo una formula che rivela appieno la commistione tra aspetti penalistici e civilistici dell’istituto. Rileva, in proposito, anche la recente entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, il cui art. 3 disciplina la sospensione del processo con messa alla prova finalizzata all’estinzione del reato, legata anch’essa al risarcimento del danno. La condotta del reo, concretatasi nel risarcimento del danno subito dalla vittima, rappresenta dunque un momento di passaggio verso la risocializzazione dell’autore del reato. A tale principio se ne deve aggiungere un altro, più moderno, che sottolinea la funzione riparatoria del risarcimento del danno anche in materia penale e che deve integrarsi con la pretesa del legislatore che tale riparazione, ai fini di attenuazione o di estinzione del reato, intervenga prima dell’ordine giudiziale, prima del processo e dell’accertamento del danno con la relativa pronuncia di condanna che ne consegue.
10.6. Senza giungere a sposare la concezione dottrinaria che vede nel risarcimento del danno nel diritto penale una terza forma di sanzione, si deve tuttavia ricordare sia l’attuale tendenza del legislatore a ridimensionare l’ambito di applicazione della pena detentiva, sempre più intesa come extrema ratio, sia la crescente rilevanza attribuita nel processo penale alla vittima del reato.
Nella stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento al principio del fair trial dettato dall’art. 6 CEDU, posto in relazione alla sorte della vittima del reato, si rinviene l’affermazione per cui la Convenzione non si può disinteressare dei diritti che le vittime di reato possono rivendicare nell’ambito del diritto e della procedura penale (Corte EDU 24/02/2005, Sottani c. Italia); sono, del resto, noti i principi espressi a livello internazionale a proposito del trattamento giudiziario che deve essere riservato alle cosiddette vittime vulnerabili (cfr.
Dichiarazione ONU del 29/11/1985, alcune Raccomandazioni approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa e la Decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale del 15/03/2001), la cui condizione non può che assumere rilievo nel giudizio di bilanciamento degli interessi dei protagonisti del processo. Nè possono trascurarsi le istanze provenienti dalla concezione teorica di un diritto penale di stampo “conciliativo” o di una “giustizia ripartiva” o “senza spada”, sebbene più orientate alla definizione dei processi concernenti reati contro il patrimonio.
10.7. Poste tali premesse, che devono orientare l’interprete a riconoscere la funzione lato sensu sanzionatola del risarcimento del danno nel momento in cui il diritto penale si appropria di tale istituto civilistico, non si deve, tuttavia, trascurare di esaminare quali siano i rapporti con il giudizio risarcitorio di natura prettamente civilistica, allorchè l’istituto così descritto venga calato nel dispiegarsi della vicenda processuale penale mediante l’esercizio dell’azione civile. Parti necessarie del processo penale sono, infatti, solamente il pubblico ministero e l’imputato; da ciò deriva il principio per cui l’azione penale non può subire rallentamenti a causa dell’esercizio delle azioni extrapenali.
10.8. Non si può trascurare, dunque, che il danneggiato dal reato è parte accessoria del processo penale; si distingue dalla persona offesa dal reato in quanto quest’ultima è colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l’azione civile nel processo penale.
Mentre la persona offesa dal reato gode della tutela di natura pubblicistica correlata all’interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l’eccezionale ipotesi di cui all’art. 77 c.p.p., comma 4, ed è pertanto tenuto ad esercitare l’azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell’onere probatorio. Sebbene normalmente persona offesa e danneggiato coincidano, la distinzione è fondamentale per riconoscere i differenti poteri riconosciuti a tali soggetti nell’ambito del processo penale, basati fondamentalmente sulla funzione di accusa privata riconosciuta alla persona offesa dal reato che, in virtù di tale funzione, sola può opporsi alla richiesta di archiviazione (art. 410 cod. proc. pen.), ovvero presentare memorie finalizzate alla valutazione delle prove ed all’interpretazione delle norme in senso eminentemente rafforzativo dell’accusa pubblica (art. 90 cod. proc. pen.). Dal punto di vista della legittimazione processuale, la distinzione tra persona offesa e danneggiato civile si apprezza chiaramente dal raffronto tra i criteri di scelta del rappresentante del minore nell’esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla persona offesa nel processo penale (art. 90 c.p.p., comma 2) e le regole che disciplinano la rappresentanza del minore nell’esercizio dell’azione civile (art. 77 cod. proc. pen.), modellate sul paradigma della rappresentanza dell’incapace nel processo civile, oltre che dal fatto che neppure in caso di urgenza al pubblico ministero è consentito esercitare i diritti della persona offesa, non rinvenendosi nel codice norma analoga a quella posta dall’art. 77 c.p.p., comma 4, con riguardo al danneggiato. La persona offesa dal reato, la vittima del cosiddetto danno criminale, viene comunque messa in condizione di esercitare l’azione civile (art. 419 c.p.p., comma 1, art. 429 c.p.p., comma 4 e art. 456 c.p.p., commi 3 e 4) laddove sia anche persona lesa civilmente, ossia abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale civilmente apprezzabile, dunque risarcibile, mantenendo altrimenti le prerogative proprie della persona offesa dal reato che non sia anche danneggiato civile.
10.9. Tale precisazione si è resa necessaria per inquadrare dal punto di vista soggettivo il tema più generale della tendenziale indipendenza tra giudizio penale e giudizio civile, anche quando quest’ultimo si svolga nell’ambito di un processo penale, secondo quanto consentito dall’art. 74 cod. proc. pen. Si parla di tendenziale indipendenza perchè, nonostante la disciplina processualpenalistica sia oggi indirizzata a limitare le contaminazioni tra il giudizio espresso con riferimento all’accusa penale ed il giudizio inerente al danno risarcibile da reato (ne sono un concreto esempio le norme che regolano l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno, artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), occorre tuttavia distinguere le situazioni nelle quali si verifichino reciproche influenze tra i diversi rapporti processuali dalle situazioni in cui si confermi la predetta indipendenza. Senza estendere oltre il necessario l’ambito della presente motivazione, si allude ai casi nei quali la commissione del reato abbia prodotto, oltre all’offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato e quest’ultima abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale, scegliendo dunque di limitare la propria pretesa, nell’ambito dei più ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall’art. 185 cod. pen..
10.10. Quanto alle ragioni di tale scelta, va detto che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale comporta, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l’accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che, come già detto, l’azione penale non può subire rallentamenti a causa dell’esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l’incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull’onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv.
244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep. 2005, Dorgnak, Rv.
231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema “aperto” dell’azione civile nel processo penale, consentendo all’autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda. Il sistema regola, dunque, l’ipotesi propria del caso in esame, in cui la parte civile ha optato per la domanda di condanna generica, con una allegazione altrettanto generica del danno, ed il giudice ha ritenuto accertata l’entità dannosa del fatto addebitato, valutando, in altre parole, che nel processo civile non vi fossero margini di sviluppo di detta allegazione e della prova del danno.
10.11. Nè si può ignorare che, oltre ai vincoli che l’esercizio dell’azione civile incontra nel processo penale, è ora anche venuta meno l’originaria risarcibilità del danno non patrimoniale in esclusiva concomitanza con il reato, sia ad opera di numerose leggi speciali (ad es. L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15), sia in seguito alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. espressa dalla Cassazione civile nel 2008 (Sez. 3 civile, nn. 8827 e 8828 del 31/05/2008; Sez. U civili n. 26972 del 11/11/2008 n. 26972, Rv.
605491), che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona, non solo quando l’illecito costituisca reato ma anche quando l’illecito abbia leso diritti inviolabili della persona. Deve ritenersi che il danneggiato dal reato, attualmente, opti, quindi, di inserirsi nel meccanismo del processo penale, rinunciando alle più articolate scansioni del rito civile in cui la domanda risarcitoria verrebbe ad assumere il ruolo di domanda principale, esclusivamente in vista della maggiore pressione che il processo penale potrebbe esplicare sull’autore del danno per indurlo a soddisfare la sua pretesa risarcitoria.
10.12. E’ bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza perchè sia soddisfatto l’obbligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver distinto le singole voci di danno giacchè in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice, nel caso in esame ampiamente osservato, di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez. 3 civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv. 621460; Sez. 3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.
589068; Sez. 3 civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv.584526; Sez. 3 civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv. 564299).
10.13. Per un completo esame della censura, va anche ricordato il principio già enunciato al punto 2.3.
11.1. E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale “La responsabilità diretta non si attaglia alla figura del responsabile civile, che è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 cod. pen. e art. 83 cod. proc. pen.. Ne consegue l’illegittimità della decisione che affermi la responsabilità diretta del responsabile civile e non già per fatto altruì” (Sez. 4, n. 10701 del 01/02/2012, Baraiolo, Rv.
252674).
11.2. Conseguentemente, costituisce errore di diritto l’affermazione contenuta a pag. 39 della sentenza secondo la quale il Comune di Brescia risponde civilmente nel presente processo “essendo del tutto evidente che le condotte del M., da solo o in concorso con altre persone, sono state consentite ed agevolate dalla insufficiente vigilanza sui bambini, certamente dovuta a precise carenze organizzative e di controllo delle attività scolastiche che si svolgevano nel plesso della scuola (OMISSIS), attività che dovevano essere predisposte dall’Ente e di cui lo stesso era garante nei confronti dei piccoli affidati all’istituto scolastico e dei loro genitori”.
11.3. Tanto più ove si osservi che tale punto della decisione era stato già deciso dalla Corte di legittimità con sentenza n. 39994/2007, con la seguente statuizione: “Infondata è, per contro, la censura sub 3), relativa al preteso difetto del nesso di immedesimazione organica o di occasionalità necessaria tra i fatti di reato e le mansioni svolte dal M.. Questa Corte, con orientamento ormai pressochè costante, ha individuato nella cosiddetta “occasionalità necessaria” il criterio di collegamento della responsabilità solidale da atto illecito della P.A. per i fatti commessi dai propri dipendenti, ritenendo che all’esclusione possa pervenirsi nei soli casi in cui gli atti compiuti e debordanti dai compiti istituzionali assumano il carattere dell’assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto a questi ultimi, al punto da non consentire il minimo collegamento con gli stessi: solo in tali casi, di mera occasionalità accidentale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione va esclusa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 11/6/2003, n. 33562, Cordaro ed altri; Sez. 3, 2/7/2002, n. 36503, Cerullo ed altri). Nel caso del M., inserviente presso la scuola materna, con precise mansioni di accompagnare in bagno i bambini, di provvedere alla loro igiene ed all’eventuale cambio qualora si fossero sporcati, l’esplicazione delle mansioni di istituto si è inequivocabilmente posta quale condicio sine qua non rispetto al verificarsi dei fatti attribuitigli.
11.4. Trattandosi, in ogni caso, di errore di diritto che non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, la motivazione può essere emendata mediante richiamo all’unico titolo fondante la responsabilità del Comune, ossia il rapporto non occasionale tra le condotte delittuose ascritte al M. e l’esercizio delle mansioni svolte in quanto lavoratore dipendente del Comune, già affermato con pronuncia sul punto irrevocabile.
Il principio di diritto della necessaria coincidenza tra la somma che l’imputato deve corrispondere allo Stato e la somma che lo Stato liquida e corrisponde al difensore va confermato, con questa ulteriore precisazione. E’ vero che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, prevede che la liquidazione del compenso al difensore per il giudizio di cassazione è compito del giudice di rinvio ovvero di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. E certamente sussiste e permane tale competenza nel caso di sentenza della Corte di Cassazione che o accolga il ricorso dell’imputato o comunque compensi, del tutto o parzialmente, le spese tra le parti private: anche in tali casi, infatti, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche ha diritto alla liquidazione da parte dello Stato del proprio compenso. Quando, però, nel giudizio di impugnazione l’imputato ricorrente viene condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il generale obbligo di liquidazione – ex artt. 541 e 592 cod. proc. pen. – quale però disciplinato con norma speciale dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, con la previsione della ricordata necessità della coincidenza tra le due somme (imputato-Stato; Stato-difensore della parte civile ammessa). Pertanto, anche la Corte di cassazione potrebbe in questo peculiare caso procedere alla liquidazione. Presupposto indispensabile per la immediata liquidazione da parte della Corte di cassazione è, peraltro, l’avvenuta presentazione, come nel caso concreto, di una nota spese che risponda puntualmente, nell’indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, ai principi imposti dall’art. 82 del citato Testo unico (Sez. 6, n. 3885 del 18/01/2012, Iovine, Rv. 252135).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti civili S.D. e K.P., da un lato, M.B. E. e Comune di Brescia, dall’altro.
Condanna M.B.E. e il Comune di Brescia, in solido, al pagamento delle spese processuali relative alle parti civili N.A. e V.T., liquidate in complessivi Euro 2.691,00 oltre oneri accessori come per legge, nonchè relative alle parti civili R.F. e G.V., liquidate in complessivi Euro 2.691,00 oltre oneri accessori come per legge e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015
***
Il paper lo trovi qui sotto o lo scarichi cliccando QUI.
Si può lucrare sul compenso dell'avvocato_ Un caso nel gratuito patrocinio?
3 Comments